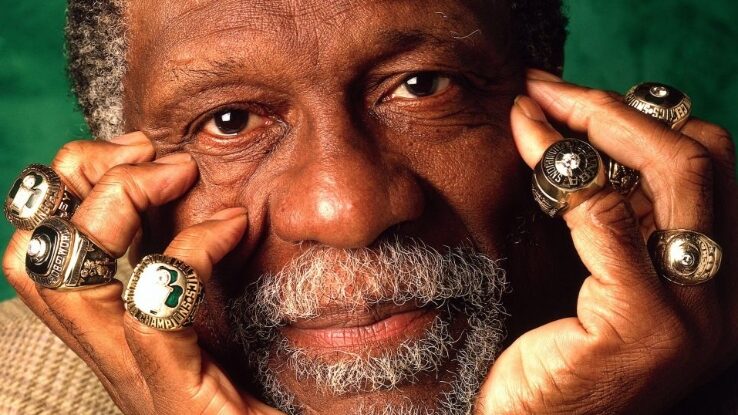Un tributo a una squadra iconica, giovane e spettacolare – e perdente – che ha segnato uno spartiacque netto tra il basket degli anni ’90 e quello del nuovo millennio.

Chiunque abbia un minimo di trent’anni e una passione per il Gioco che lo accompagni dall’infanzia, ricorderà di aver avuto, con l’avvento del nuovo millennio, l’irrefrenabile necessità di acquistare una fascetta da mettere sulla fronte per giocare a qualunque livello, dal CSI al campetto ai campionati juniores. E una volta indossata, ad ogni canestro fatto – anche il più banale dei terzi tempi – un doppio colpetto dei pugni sulla stessa certificava l’emulazione di un rito di un gruppo di giovani canaglie in maglia Clippers che travolsero la NBA con un entusiasmo di cui la stessa sentiva un gran bisogno.
La fine degli anni ’90 portava con sé una fitta coltre di stanchezza sopra la Lega e i suoi tifosi, tutti estremamente provati dall’intenso decennio jordanesco, chiusosi di fatto con l’anno del lockout, un lunghissimo teatrino che dimezzò l’annata seguente il ritiro di Sua Maestà. Dalla stagione 1998/99 a quella 1999/2000, la NBA perde oltre un milione di spettatori televisivi ed oggettivamente lo spettacolo offerto, soprattutto durante la regular season, lascia il tempo che trova.
È l’anno della cavalcata trionfale dei Lakers, che registrano il miglior record stagionale e che – tranne il singhiozzo contro i meravigliosi Jail Blazers – arrivano fino alle Finals, conquistate conto i Pacers grazie alla prima comunione d’intenti finalizzata al dominio di Shaq & Kobe. Ma è sull’altra sponda del Los Angeles River che vogliamoci soffermarci, perché quella stessa estate, in casa Clippers, inizia un breve quanto superfluo – quanto inebriante – esperimento.
L’anagrafe dei cinque membri chiave della squadra recita: Darius Miles, 18 anni; Keyon Dooling e Quentin Richardson, 19 anni; Corey Maggette e Lamar Odom, 20 anni, con soli questi ultimi con un anno di esperienza NBA. In pratica, una squadra di college, nell’anno in cui la lega registra la media d’età più alta della sua storia, oltre i 28 anni. Questo gruppetto di adolescenti si ritrova in una realtà con bassissime aspettative, con la libertà di un gruppo di liceali che organizzano una festa quando i loro genitori lasciano la città per il weekend. La folle franchigia di Donald Sterling, con le idee molto poco chiare, decide di farsi guidare dalla loro esuberanza, che lascerà un segno indelebile nella NBA di inizio 2000, fatto di intrattenimento, stile e freschezza. Vittorie un po’ meno, diciamo…
Hanno reso divertente la sconfitta… si mettevano in mostra, crossover a destra e a manca, alley-oop, giocate pazzesche. Ho pensato: cazzo voglio andare ai Clippers e perdere insieme a quei matti.
(Baron Davis)
La signora Ethel Miles sta lavando i piatti in cucina nella torrida estate lungo le sponde del Mississippi, in quel di East St. Louis, quando dalle finestre aperte della cucina sente arrivare grida e clamore dal campetto a pochi passi da casa. Suo figlio Darius è lì, come ogni giorno, e molto preoccupata che possa essersi cacciato nei guai si precipita al playground. Del resto East St. Louis non è uno dei posti più sereni dove crescere: una cittadina di nemmeno 40mila abitanti – a est di St. Louis, appunto, ma già nell’Illinois – con il tasso di omicidi e crimini violenti più alto del Paese, comparabile con le peggiori città messicane o del centro America.
Arrivata sul posto, nota una folla di adulti esaltati, intenti a guardare una partita mista tra ragazzi e adulti. La signora chiede agli astanti a cosa sia dovuto cotanto entusiasmo e qualcuno le indica suo figlio. “Impossible, Darius ha solo 11 anni”. “Beh signora, sicuramente non li dimostra…”
Fast forward a qualche anno dopo e il giovane Darius, ora 17enne, è diventato uno dei giocatori più chiacchierati non solo dell’Illinois, ma dell’intero Paese.
È un airone elegantissimo di 206 centimetri, dall’apertura alare impressionante, che sul campo sa fare più o meno tutto, grazie a un atletismo e una genetica da segno della croce, “ingiustamente” unite a un talento puro e una tecnica difficili da trovare altrove. Televisioni e giornali sono concordi: “The next KG”, idolo assoluto di D-Miles, che per mettere il proprio nome sulla mappa ha dovuto farsi le ossa quattro ore di auto più a nord di ESL, partecipando ad ogni torneo possibile nella capitale cestistica più vicina a casa sua, Chicago.
Ad ogni viaggio era ospite a casa della famiglia Richardson, il cui figlio Quentin lega subito con Darius, oltre ad essere una sorta di leggenda urbana nella Città del vento. Con la sua scuola, Young High School, avrà perso due partite nell’arco di tutto il percorso scolastico ed è ancora oggi ricordato come uno dei più forti giocatori mai usciti dallo stato, con una mano devastante dalla lunga distanza e un agonismo secondo a nessuno.
Q-Rich ha un anno abbondante in più di Miles: mentre il primo gioca due stagioni fenomenali nel college di casa a DePaul, Darius s’impegna con St. Johns, lasciando però aperta la possibilità di andare direttamente tra i professionisti nel caso fosse stato una scelta top-5. Eccome se lo era.
È l’estate del 2000 quando i cugini sfigati di LA, reduci da una stagione da 15 vittorie (!), affidano la panchina ad Alvin Gentry: al Draft di giugno avranno a disposizione la terza e la diciottesima chiamata.
Molti esperti dicevano che la prima scelta assoluta era un 50-50 tra me e Kenyon Martin, e alla fine i Nets scelsero lui. Poi c’era Vancouver e mia madre era stata molto chiara: niente Canada per mio figlio. Alla quarta c’erano i Bulls che avevano mostrato interesse nei miei confronti ed ero convinto ed entusiasta di andare a Chicago. Invece…
(Darius Miles)
Invece i Clippers, con la terza chiamata, nonostante non abbiano mai neanche stretto la mano a Darius, decidono di selezionarlo. Quindici chiamate dopo, il miracolo: anche Quentin Richardson, rimasto a sorpresa senza squadra, viene scelto dai Clips, riunendo i due amici sotto lo stesso tetto, in una notte che difficilmente dimenticheranno, ma che non è ancora finita.
Alla decima chiamata gli Orlando Magic avevano selezionato la guardia Keyon Dooling, di fatto una scelta civetta per mano ancora una volta dei Clippers, che si accaparrano lui e il giovane sophomore Corey Maggette, cresciuto a meno di 10 minuti da Quentin Richardson, in quel di Melrose Park, Chicago. Ad attenderli in California c’è il quasi ROTY dell’anno precedente, Lamar Odom, uno dei giovani talenti più interessanti che la NBA abbia da offrire.
Il training camp che disputano quell’estate, in un junior college di South Central, LA, fortifica il legame tra Darius, Quentin, Lamar, Keyon e Corey, anche se assistendo agli allenamenti non si direbbe.
Erano delle vere e proprie battaglie, andavamo l’uno contro l’altro senza pietà, un po’ per la nostra mentalità, per come siamo cresciuti, un po’ perché volevamo metterci in mostra, essendo appena arrivati tra i pro. Ma fuori dal campo vivevamo in simbiosi ed eravamo molto amici.
(Quentin Richardson)
Questa combinazione di competitività e leggerezza tipica della loro giovane età ha degli effetti immediati sui parquet della NBA, con i Clippers che diventano un vero e proprio cult della lega. Ogni volta che partono in contropiede il pubblico comincia ad alzarsi in piedi e a trattenere il respiro, conscio che qualcosa sta per succedere. Tutte le young guns hanno un atletismo ben sopra la media e giocano con un’aggressività e un’impenitenza che generano una folta schiera di fan adoranti, fin dalle prime gare della stagione.
È come vedere una super talentuosa squadra di playground giocare tra i professionisti, alla ricerca sì della vittoria, ma mai snaturando la propria natura frizzante e spettacolare, anche a costo della sconfitta.
Odom è il faro; nei primi anni della sua carriera NBA gioca forse il suo miglior basket “puro” ed è infatti leader statistico di tutte le voci offensive e difensive della squadra. Maggette, atleta furibondo, un fisico più vicino al culturismo che alla pallacanestro, è in grado di crearsi sempre due punti dal nulla, ottimo rimbalzista e procacciatore seriale di tiri liberi. Dooling è una point guard esplosiva, anch’egli incline a viaggiare sopra al ferro e con una passione per la schiacciata in faccia ai propri avversari. E oltre ai già citati Miles e Richardson, altri personaggi di culto formano quel roster leggendario.
Come la misteriosa prima scelta del 1998, Michael Olowokandi, poco incline al sacrificio, a voler usare un eufemismo; oppure il centro di riserva Keith Closs – per sua ammissione, spesso ubriaco anche durante le partite – o l’iconico ex Duke Cherokee Parks, cresciuto da una famiglia hippie itinerante, che non ha mai rinunciato a una festa nella sua vita.
L’unico veterano del poster, con appena 30 anni compiuti, è “The Polish Rifle” Eric Piatkowski, tiratore devastante in un’epoca in cui quelli come lui dovevano solo aspettare fuori dall’arco, nella speranza che una palla prima o poi finisse nelle vicinanze, pronta ad essere sparata dalla distanza.
A tenere le briglie di questa improbabile Armata Brancaleone c’è coach Gentry, alla sua prima vera esperienza da capo allenatore: si capirà come gli analisti, all’epoca, parlassero dei Clippers come di un’organizzazione quantomeno fragile.
La stagione 2000/01 porta dunque tanto spettacolo e un po’ di attenzione in più nei confronti della franchigia, che raddoppiano le vittorie dell’annata precedente: ottimo certamente, ma come detto erano state 15, quindi anche raggiungendo 31W non si può certo parlare di un successo. Ma una luce si intravede, questo è certo.
Da un punto di vista della comunicazione, poi, le quotazioni dei Clippers esplodono improvvisamente: le maglie di Odom e Miles sono tra le più vendute dell’anno, spesso indossate da rapper e cantanti in cima alle classifiche dell’epoca. Lo stile di gioco e la moda influenzata dall’hip hop sono radicate indissolubilmente, soprattutto in D-Miles e Q-Rich, che vengono messi sotto contratto dal brand Jordan, che intravede in loro un potenziale commerciale enorme.
I due cominciano proprio in quel periodo il rito dei due colpi in testa, che prenderà il nome di Knuckleheads, diventato, una volta terminata la loro carriera, il titolo del loro fantastico podcast per The Players Tribune.
Andavamo spesso a vedere la squadra del liceo Westchester, in cui giocava gente come Trevor Ariza, Bobby Brown, Hassan Adams, erano fortissimi e quell’anno vinsero il titolo statale. Dopo l’ennesima vittoria li abbiamo visti festeggiare con quel gesto e gli abbiamo chiesto cosa fosse: loro ci hanno implorato di farlo in partita in modo che potessero vederlo in televisione. Da allora ci abbiamo preso gusto e non abbiamo più smesso.
(Quentin Richardson)
I puristi della vecchia scuola li condannano, adducendo come fosse immaturo e irrispettoso festeggiare ad ogni singolo canestro, visto poi l’esito spesso negativo delle loro gare; ma la verità è che quei ragazzi hanno riportato un senso di libertà e gioia che si stava perdendo nella lega, e che da allora è diventato uno standard.
L’anno seguente, grazie a una trade, sbarca ai Clippers il co-ROTY 2000, Elton Brand, che dopo due stagioni ottime dal punto di vista personale, drammatiche per i risultati di squadra, raggiunge un core giovane che ha bisogno di uno scorer più affidabile.
Brand porta quasi 20 punti in più a uscita, permettendo a Odom di limitarsi a un ruolo di facilitatore, in cui sentirsi più a suo agio; Richardson e Miles dalla panchina migliorano drasticamente le loro voci statistiche, e persino Olowokandi gioca la miglior stagione della sua vita, chiusa quasi in doppia-doppia di media. Brand partecipa anche all’iconico All-Star Game 2002 – grazie ancora T-Mac – diventando il primo della seconda squadra di LA dai tempi di Danny Manning nel ’94 a riuscirci.

I Clippers continuano a macinare gioco e vittorie anche dopo la sosta, arrivando al 21 marzo, dopo una vittoria esterna sul campo dei Warriors, con un record di 36 vinte e 33 perse, ampiamente in corsa per i Playoffs della Western Conference: purtroppo così non sarà. Forse per la pressione per un obiettivo inaspettato improvvisamente alla portata, forse per l’atavica necessità dei Clippers di complicarsi la vita, la squadra perde 10 delle ultime 13 gare stagionali, mancando la post-season di una manciata di vittorie.
È stata una brutta botta, ma era chiaro che eravamo in ascesa, bastava tenere quel core per altre due stagioni aggiungendo qualche buon giocatore e avremmo potuto competere seriamente. Sette di noi avevano ancora rookie deals, la dirigenza poteva permettersi di tenerci e andare a caccia di qualche grosso free agent senza problemi. Hanno fatto scelte diverse.
(Darius Miles)
La società, nella persona dell’allora executive Elgin Baylor, decide di scambiare Miles per Andre Miller, con un solo anno di contratto, convinto che la sua leadership in regia fosse più necessaria dell’entusiasmo giovanile del ragazzo di East St. Louis. Miller, dal carattere particolare, non si ambienta ai Clippers, peggiorando tremendamente le proprie prestazioni in termini numerici, parlando poco con staff e compagni, e lasciando la California nella free agency successiva, per raggiungere Denver.
Sempre il front office, inoltre, dubbioso all’idea di prendere un altro liceale dopo l’esperienza Miles, decide di passare un altro teenager di cui si fa un gran parlare, un certo Amar’e Stoudemire, preferendogli Chris Wilcox da University of Maryland…
È una stagione che parte male, prosegue malissimo – tra infortuni e licenziamento di coach Gentry – e finisce con un numero di vittorie inferiore all’annata precedente. In generale, è una stagione che lascia trasparire un’involuzione di squadra, la perdita di un momentum – come dicono gli americani – un periodo di positività ed entusiasmo che andava cavalcato piuttosto che soffocato.
Sono state due stagioni quasi magiche, dopo anni di umiliazioni. Questi ragazzi hanno portato freschezza e divertimento, portando gioia e amore per il Gioco che ai Clippers si erano persi completamente.
(Ralph Lawler, cronista dei Clippers)

Una volta smantellata la banda degli enfants terribles, i Clips proseguiranno il loro percorso verso la costruzione di un’identità credibile all’interno della Lega – cosa avvenuta davvero solo dopo il 2011, con l’approdo di Chris Paul e l’inizio dell’era Lob City.
Se l’estrema fiducia data a un gruppo così giovane fu senza dubbio una mossa audace e da ricordare, la scellerata gestione da parte di Sterling e il suo staff grida ancora vendetta, sia per gli spettatori imparziali ai quali è stato impedito di godere di un unicum all’epoca, sia per i tifosi Clippers che avevano cominciato a intravedere un lumicino al termine di un tunnel infinito.
Lungi da far passare quelle due stagioni come memorabili pagine di storia della pallacanestro. Resta però difficile non notare una linea di continuità tra quei cinque under 21 allo sbaraglio, con la loro attitudine e la loro forza dirompente col passato, e il basket moderno, in cui atleti sempre più giovani e forti si danno battaglia ai più alti livelli, senza mai risparmiarsi sull’esprimere se stessi, attraverso abbigliamento, esultanze, gestualità, balletti o checchessia.
In un’epoca come la nostra, piena di risultatisti, freddi burocrati che misurano la grandezza di squadre e atleti solo in base ai loro palmares, un pensiero per questi team belli e perdenti serve a mantenere vivo un concetto che la mera utilità non potrà mai portar via del tutto dal Gioco: anche l’occhio vuole la sua parte.