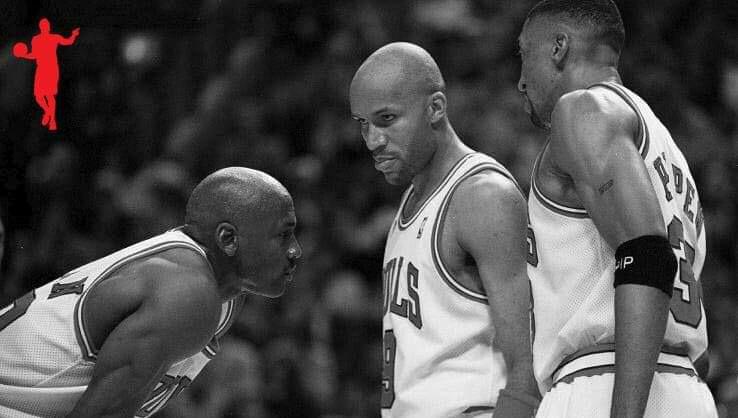Parabola della vita cestistica di Shawn Marion, autentico precursore del “Positionless Basketball”.

Erano i primi anni di questo secolo, il mondo stava cambiando, ma non sapevamo ancora quanto. L’NBA e il basket stavano cambiando, ma non sapevamo ancora come. Ad anticipare il trend, a fare da pionieri di un nuovo verbo cestistico, Mike con il “baffo” e tre suoi apostoli. Steve, Amar’e e Shawn. Di questo quartetto – di cui molto si è scritto, altrettanto si è detto – il più snobbato, ma non meno importante, il buon Marion, Shawn Marion, per tutti the Matrix. Lui più degli altri avrebbe peraltro meritato – sempre per rimanere in tema cinematografico – la parte del protagonista in “Back to the Future”, dove da novello Marty McFly prestato al basket, non avrebbe sfigurato nell’interpretare il ragazzo che a bordo di una DeLorean arriva nel passato, da un futuro fatto di basket senza posizioni e di ruoli “liquidi”. In quel passato dove grazie al suo approccio e alla sua versatilità avrebbe anticipato il nuovo corso del gioco, magari non sempre capito, magari spesso sottovalutato.
Sottovalutato per una questione di numeri, una questione di carisma, una questione anche di talento, naturalmente. Cosa che Shawn ha accettato di buon grado. In attesa che il tempo gli desse, ancor più, ragione. Quel tempo che lui ha sfidato, risalendone lo scorrere e accorciandone il battito. Shawn Marion è stato tra i precursori – se non il primo profeta – del “Positionless Basketball“, di cui oggi tutti si riempiono la bocca. Ala piccola nominale di poco più di 2 metri, in grado di ingaggiar tenzone in post, così come di difendere almeno altre due, se non tre o quattro, posizioni. Di catturare il rimbalzo e riempire le corsie in transizione, di occupare le linee di passaggio a caccia di palloni, di allargare il campo col suo tiro, brutto da vedere – oh se era brutto, signora mia – ma velenoso. E naturalmente capace di fluttuare in volo in aria per un tempo non misurabile con i canoni umani. The Matrix, appunto.

Il giovane Marion, come avrebbe fatto anche nel resto della sua avventura cestistica, inizia a farsi notare scegliendo un percorso tortuoso, quasi “contromano”. Nato in Illinois, in una cittadina poco a nord di Chicago, il nostro comincia a riempire i canestri a livello scolastico in una high-school del Tennessee, per poi scegliere – in maniera abbastanza sorprendente – un junior college dell’Indiana, Vincennes, dove anni prima era transitato anche Bob McAdoo, dove farà sfracelli, restando ai margini però dalle luci della Division I. Élite collegiale alla quale invece approda al suo terzo anno, quando si trasferisce a UNLV, il serbatoio universitario del basket di Vegas.

In Nevada Shawn continua a bruciare retine e consolida il suo status tra gli scout dell’intera nazione. Promette di concludere il ciclo scolastico, ma poi le sirene del professionismo lo ammaliano e quando sente parlare di potenziale approdo in lotteria cede, scegliendosi un agente e dichiarandosi per il draft. Siamo nel 1999, Shawn ha da poco compiuto 21 anni e sente il suo nome chiamato alla 9 dai Phoenix Suns. Arizona here I come.
I Suns di fine millennio sono una squadra in evoluzione, appena transitati dall’era Charles Barkley, alla ricerca di una nuova dimensione. Non ancora il laboratorio degli anni a venire, ma una realtà che, con Scott Skiles in panchina, con i Colangelos – Jerry e Bryan, padre e figlio – a passarsi il testimone come GM e con Jason Kidd e Penny Hardaway nel backcourt, cominciava a piantare i semi di quei virgulti che sarebbero pienamente sbocciati all’alba nuovo secolo.
In questo contesto atterra Shawn Marion, un breve adattamento e già al secondo anno scala rapidamente le gerarchie per mettersi in luce come una delle pedine funzionali ad un sistema che olia quei meccanismi offensivi che diventeranno un marchio di fabbrica da lì a qualche stagione. A lui piace giocare con Jason Kidd, forse il play – tra i tanti celeberrimi con i quali ha diviso lo spogliatoio – che più riempirà il suo cuore. È Jason il primo ad “accenderlo” al piano di sopra, sarà Kidd a fargli compagnia, tanti anni dopo nella cavalcata che porterà entrambi al primo ed unico titolo personale, a Dallas. Ma non corriamo troppo.
Non corriamo, perché a correre ci pensano già i giocatori che calcano il parquet della Valley of the Suns. Nel 2003 Shawn si conquista la prima partecipazione all’All-Star Game. Al posto di Giasone in regia c’è Stephon Marbury, ad un calante Tom Gugliotta si sta sostituendo un emergente Amar’e Stoudemire. Marion è invece stabilmente una sicurezza. Il meglio deve ancora arrivare.
Il meglio comincia ad arrivare a partire dall’anno successivo, dal 2004. A volte ritornano, così si dice. Così fa Steve Nash – che dai Suns era stato scelto, tra i fischi dei tifosi, nel 1996. Mike D’Antoni siede fin da inizio stagione in panchina. Ed è così che l’accoppiata di fosforo e visione comincia a perfezionare il “Seven Seconds or Less”, la formula magica che spingerà Phoenix – “così de’ botto senza senso” – a superare le 60 vittorie in stagione, forti del miglior offensive rating della Lega. Un treno in corsa. Solo San Antonio li farà deragliare nelle finali di Conference. È nel corso di quella magica stagione, che vede un miglioramento monstre di 33 vittorie rispetto all’anno precedente, che Steve Nash sarà per la prima volta MVP, Mike D’Antoni Coach of the Year, con Amar’e e il nostro Shawn a rappresentare con Steve i Soli all’ASG. Un filotto di riconoscimenti personali.

Formidabili quelle stagioni, per tre anni consecutivi i Suns – pur colpiti da innumerevoli traversie – si distinguono per condurre delle cavalcate vincenti nella regular season e prolungate corse ai playoff. Corse che irrimediabilmente si interrompono a pochi passi dal traguardo, contro i muri di altre superpotenze ad Ovest, per due volte gli Spurs, una i Mavs.
Finché il meccanismo si inceppa, il giocattolo si rompe, per una serie di motivi. Dai cali motivazionali, agli infortuni e non da ultimo, la difficoltà a mantenere la chimica giusta nell’ambiente. Non sarà un caso se, nel Febbraio del 2008, Shawn Marion viene scambiato per Shaquille O’Neal e quella mossa segna un punto di non ritorno per la franchigia di Phoenix. Non solo uno scambio, ma una vera e propria abdicazione ai princìpi fondanti del sistema di quei Suns. Un mutamento di DNA irreversibile. Giù il sipario su una delle rappresentazioni più eccitanti della NBA degli anni 2000.
Per Shawn Marion finisce l’esperienza del “teatro stabile” di Phoenix, per iniziare quella da guitto itinerante, con la valigia sempre in mano. Uno stop trascurabile a Miami, un passaggio deludente a Toronto. Shawn sembra un attore che sta passando inesorabilmente di moda, pronto per imboccare il viale del tramonto. E invece no.
Dallas lo cerca. Il management dei Mavericks è cosciente che la finestra del “prime” di Dirk Nowitzki si sta lentamente, ma inesorabilmente, chiudendo e si muove per costruire attorno al Tedesco, la compagnia che lo possa portare al titolo.

Alcuni passaggi di questa nuova esperienza non sono però affatto semplici per Marion. Dopo anni di starting five, si deve accomodare in panchina, un declassamento che Shawn – competitor indefesso – mal sopporta. I suoi numeri si abbassano, nessuno che gli chiami un gioco, le sue prestazioni sempre più marginali nell’economia della squadra.
Poi la svolta, travestita come càpita ogni tanto, dall’infortunio di un compagno – Caron Butler. Shawn ritrova il quintetto, la fiducia, le motivazioni per incidere ancora da par suo. Marion contribuirà in maniera sostanziale alla corsa dei Mavs verso il titolo. Prima come sparring-partner in allenamento negli uno-contro-uno con Wunder Dirk, così da abituarlo a reagire allo small-ball usato contro di lui, poi con alcune graffianti prestazioni in attacco e soprattutto con solide uscite difensive, specialmente nelle Finals dove fu cruciale per contenere Sua Maestà LeBron James. Un colpo di coda da fenomenale stopper, per un giocatore incredibilmente ignorato in tanti anni di onorata militanza in retroguardia, al momento di assegnare i riconoscimenti difensivi individuali e di squadra.
Dopo il top poco altro, qualche cartuccia sparata ancora a Dallas, poi un breve passaggio ai Cavs, giusto per vedere se la sorte avesse riservato per lui qualche altro scampolo di gloria. Ma il declino fisico non gli dà tregua. Arriva il tempo di dire addio.
L’eredità che Shawn lascia all’NBA sta nei numeri e nel gioco.
Nei numeri, che dicono primo giocatore a raggiungere 17.000 punti, 10.000 rimbalzi, 1.500 rubate, 1.000 stoppate e 500 triple segnate in carriera. Il secondo di due a raggiungere almeno 15 punti, 8.5 rimbalzi, 1.5 rubate e 1 stoppata di media. L’altro si chiama Hakeem Olajuwon, per dire.
Nel gioco che, anche a partire dalla sua impronta, si svilupperà privilegiando giocatori atletici, ma non privi di tecnica, capaci di macinare chilometri, ma anche di riempire gli spazi con il proprio corpo e con il proprio intuito, di coprire più ruoli, anzi di non assumerne alcuno e giocarli tutti.
Capace di volare in alto e restarci all’infinito, in una curva spazio-temporale frequentata da pochi, ma abitata da Shawn the Matrix Marion. Lui che veniva dal futuro.