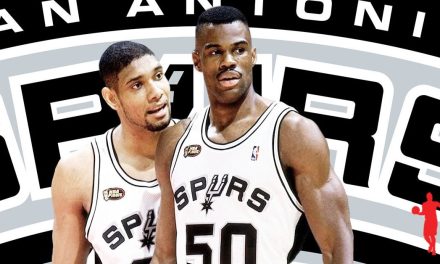Nel 1991, Charles Barkley si rese protagonista di uno sputo all’indirizzo di un tifoso dei Nets, colpendo accidentalmente una ragazzina. Una camera d’albergo e una cameriera senza peli sulla lingua gli diedero l’opportunità di riflettere sulla sua vita e sulla sua carriera.

BEEP
BEEP
BEEP
B…
Al quarto beep, la signora Mabel spense la sveglia digitale che i suoi figli le avevano regalato per Natale. L’avevano comprata da Macy’s durante il Black Friday, venendo alle mani con una distinta casalinga assetata di sangue. Era costata $59.99 e un labbro scucito, ma per loro il tempo era davvero denaro. Philmore faceva il custode e Mabel la cameriera, vivevano su ritmi molto diversi dal resto del mondo e non potevano permettersi di essere in ritardo. Per anni si erano affidati alla vecchia Bessie, appartenente alla famiglia da generazioni. Aveva sempre funzionato alla perfezione, ma una mattina Philmore l’aveva fatta finire per terra una volta di troppo.
La signora Mabel si pelò lenta dal letto caldo, barcollando verso il bagno. Riemersa dalla doccia, indossò con cura l’uniforme seminuova che l’Hilton le aveva fornito a sue spese tre anni prima. Mise la cuccuma sul fornello, si truccò, infilò scarpe da lavoro dalle suole consunte e, riempito il termos di caffè, afferrò il cestino da pranzo. Chiuse la porta di casa con il tocco sapiente di chi non disturba.
Scese le scale, si diresse frettolosa verso la Gertrude. Non c’era tanto da cincischiare: Springfield-Belmont non era zona residenziale. La Gertrude, in onore della zia che le aveva lasciato i soldi per acquistare quell’ammasso di lamiere, ansimò un paio di volte e poi si decise a mettersi in moto. La signora Mabel s’immise nella strada deserta, imboccando rapidamente la NJ 21N diretta a East Rutherford. Era un mattino limpido e sembrava quasi che Dio, per una volta, si fosse ricordato del New Jersey. Accese la radio, come sempre. Niente di meglio di un gospel per iniziare la giornata.
Mentre cercava di sintonizzarsi sulla sua amata WAWZ, tra i latrati del DJ captò qualcosa a proposito di un certo Charles Barkley, un atleta che aveva sputato addosso a qualcuno la sera prima. La cosa stava facendo il giro del Paese e si invocava un’immediata sospensione, una multa esemplare. Persino la galera.
La signora Mabel aveva sentito abbastanza. Tornò sulle 99.5 FM e si stirò l’ugola su una granitica versione di Amazing Grace. Arrivò all’ultima strofa mentre parcheggiava la Gertrude nel posto macchina del personale. “Amen, Signore, amen”, disse a voce alta, sentendosi pompare il sangue nelle vene. Afferrò il cestino da pranzo, il termos e si avviò verso l’entrata di servizio con Amazing Grace sulle labbra.
La cucina dell’Hilton, come sempre, era in fermento. Tra poco sarebbero scesi per la colazione i primi clienti che quel 27 marzo 1991 avrebbero preteso, come sempre, pancetta croccante, succo d’arancia fresco e frittelle alte un dito serviti senza aspettare, creati dal nulla per magia. Il tutto, ovviamente, innaffiato da dosi industriali di caffè bollente.
La signora Mabel, aggirati due cuochi messicani che si pigliavano a parolacce mentre preparavano una montagna di uova strapazzate, andò a prendere il foglio di lavoro.
“Buongiorno signor Lomax”.
“Buongiorno Mabel. Ecco qui la lista delle stanze da riordinare. Abbiamo una squadra di basket che ha preso tutto il corridoio dalla 1220 alla 1240 per cui quelle camere falle per ultime. Lo sai che a quelli piace fare tardi.“
“Va bene signor Lomax.”
Recuperato il carrello delle lenzuola e dei detergenti, si infilò nell’ascensore di servizio e schiacciò il tasto dell’ultimo piano, dove si trovavano le prime camere da preparare per i clienti. Il rituale era sempre lo stesso: pulizia a fondo del bagno, poi era la volta dei letti da rifare e infine, aspirapolvere e straccio sui pavimenti. Alla signora Mabel non dispiaceva, però – si infilava le cuffie e ascoltava Smokey Robinson, canticchiando Tears of a clown mentre raccoglieva la polvere, il walkman infilato nella tasca del grembiule.
Si mise al lavoro, rassettando con i gesti esperti e precisi di chi non può permettersi di perdere tempo. Terminato di sistemare l’ultimo piano, spinse il carrello fino all’ascensore. Premette il tasto del terz’ultimo piano, dato che al penultimo c’erano le stanze che andavano dalla 1220 alla 1240. Non osava pensare a cos’avrebbe trovato lì dentro. Nel corso degli anni aveva raccolto di tutto, ma sportivi, rockstar e attori erano i peggiori: si portavano appresso facce da galera e signorine molto poco vestite, e lei finiva sempre per buttare via bottiglie vuote, mozziconi di sigarette, profilattici usati e polveri sospette che era meglio non sapere cosa fossero. L’ultima volta aveva trovato delle pipe da crack che aveva gettato nel sacco dell’immondizia evitando di farsi troppe domande. Rabbrividì. Proprio non aveva voglia di farle, quelle stanze. Ma veniva pagata per quello.
La porta dell’ascensore si aprì e Mabel si diresse verso la fine del corridoio, dov’erano le suite. Quella camera risultava vuota per cui si trattava solo di dare una rinfrescata all’ambiente, era sicura di trovare tutto pulito.
Una zaffata di whisky, sudore e puzza di fritto la colpì in piena faccia come una frustata. Il grugnito improvviso del gigante che russava a pancia in giù sul letto ancora fatto la fece sobbalzare e chiuse la porta di colpo. Si affrettò a passare oltre, appena in tempo per udire un “Vaffanculo e lasciami dormire!” soffocato in lontananza.
No, decisamente quella camera non era vuota. Meglio ripassare più tardi.

DRIIIN DRIIIN
DRIIIN DRIIIN
DRIIIN DRIIIN
DRIIIN DR…
Al quarto drin drin riuscì finalmente a trovare la cornetta a tentoni. Senza neanche alzare la faccia dal cuscino, bofonchiò un: “Che c’è?”, la voce impastata dall’alcol. “Buongiorno signor Simpson, sono le 7.30, è la sua sveglia, come da lei rich...”. Non gli fece neanche finire la frase. Che lo lasciassero dormire in pace.
DRIIIN DRIIIN
DRIIIN DRIIIN
DRIIIN DR…
“Che c’è?”
“Chuck! Sono io.”
“Ehi”.
“Ma che cazzo ti è preso ieri, Chuck?! Ti rendi conto di quello che hai fatto?”
“Non è la fine del mondo, dai.”
“Non è la fine del mondo?! Hai sputato addosso a un tifoso in diretta nazionale e hai preso una ragazzina di 8 anni. Mi spieghi come non è la fine del mondo?! I giornali e le TV vogliono Charles Barkley bandito dalla Lega, c’è persino chi chiede di sbatterti al fresco. Adesso come ce ne tiriamo fuori? Io i miracoli non li faccio. Sono il tuo agente, mica Gesù Cristo!”
“Occupatene e basta.” E gli sbattè il telefono in faccia. Non aveva abbastanza ossigeno al cervello da poterci pensare.
Cercò faticosamente di riaddormentarsi, ma evidentemente non era destino.
DRIIIN DRIIIN
DRIIIN DR…
“Chi cazzo è stavolta?”
“Charles, sono Rod Thorn.”
Riuscì con enorme sforzo a sollevare la testa dal cuscino. Gli faceva un male cane, ma quella chiamata doveva ascoltarla. Se il vicepresidente operativo della NBA, colui che di fatto faceva il cane da guardia all’immagine della Lega e comminava multe e sospensioni, si era preso la briga di farsi sentire, vuol dire che l’aveva fatta grossa. E neanche registrarsi al check in dell’hotel come Homer Simpson per non farsi trovare era servito a niente.
“Sì, Rod.”
“Come sei messo?”
“Sto smaltendo una sbornia.”
“Si sente. Allora ti lascio rimetterti in sesto. Chiamami più tardi.”
“OK.”
Posò la cornetta sul comodino per non sentire altri scocciatori e crollò con la faccia nel materasso. Sapeva di essere nei guai. Non aveva senso cercare di dormire ancora, per cui si decise finalmente ad alzarsi.
Raccolse le energie e, centimetro per centimetro, riuscì non si sa come a sollevare tutti e centoventi i chili che si condensavano su quel corpaccione. Gli si era addormentata una gamba durante la notte e crollò di nuovo col sedere sul letto. Dovette fare una fatica enorme per rimettersi dritto e, trascinando i piedi, si diresse verso la finestra. Sapeva che gli avrebbe fatto un male dannato, ma tanto valeva togliersi il pensiero. Aprì le tende e la luce del giorno gli mandò una sciabolata in direzione del nervo ottico.
Gesù che dolore. Si sentiva pulsare le tempie e gli sembrava di avere a freight train running in the middle of the head, per citare un prodotto della vicina Freehold, un mezzo italiano che si faceva chiamare The Boss.
La distanza tra il letto e il bagno gli parve eterna. Aveva gli occhi mezzo incollati dal sonno ma riuscì a distinguere in qualche modo il box doccia e ci si ficcò dentro, benedicendo con sollievo pagano il getto di acqua bollente che gli percorse la schiena, riportandolo alla vita.
Rimase immobile per qualche minuto con il mento gocciolante e poi, lentamente, iniziò a insaponarsi. A ogni gesto la sua psiche sembrava ridestarsi, i pensieri si riassemblavano come le tessere di un mosaico. Il relitto che pochi istanti prima faticava a reggersi in piedi stava tornando umano. Stava tornando Charles Barkley.
Cercò di ricostruire cosa ci facesse lì e cos’era successo la sera prima. Era in trasferta e avevano giocato contro i New Jersey Nets, perdendo ai supplementari. Aveva fatto una partita normale, niente di diverso dal solito. 32 punti e 17 rimbalzi. Il problema non era lui, erano quelle altre pappemolli che si trovava in squadra.
Hersey Hawkins, che qualcuna l’aveva buttata dentro, aveva tirato di merda; Ricky Mahorn, che il Signore lo benedica, aveva provato a metterci una pezza con qualche canestro e tanto gioco sporco, ma dopo loro tre il vuoto, ad eccezione di Andre Turner dalla panchina. E sì che i Nets ne avevano vinte forse 20 quest’anno, la metà dei suoi Sixers. Manco contro questi erano riusciti a portarla a casa.

La partita stava già andando male di suo quando alla fine del quarto periodo, uno dei consueti rompipalle aveva passato il segno. Di solito era abituato agli insulti, in un certo qual modo se la godeva anche a far arrabbiare la gente. Quello però aveva esagerato. L’aveva invitato a tornare nei campi di cotone e aveva chiamato in causa sua madre, alzandosi dal suo posto e procedendo verso di lui con fare quantomeno aggressivo. E la cosa non gli era andata a genio. Per cui si era voltato in direzione di quello stronzo, gliene aveva dette quattro e aveva lasciato partire un proiettile dalla bocca. Aveva continuato a giocare senza pensarci su, era stato fin troppo buono secondo lui. Ma dopo erano cominciati i guai.
Arrivato nello spogliatoio, frustrato per la sconfitta, sudato e pieno di lividi, si era trovato un registratore praticamente sotto il naso. Un giornalista, uno di quegli imbrattacarte che si guadagnano da vivere rovistando nell’immondizia altrui, gli aveva chiesto come si sentiva ad aver sputato addosso a una ragazzina. Lui aveva spalancato gli occhi e aveva raccolto la propria mandibola dal pavimento. Chi?
E poi si era ricordato che forse c’era qualcun altro seduto nelle vicinanze di quell’imbecille. Poteva aver intravisto una bambina di non più di dieci anni, ma capirai: in un palazzetto di diecimila e passa persone non puoi vedere tutti. Doveva averla colpita per sbaglio.
Aveva spostato il registratore con una manata e lanciato all’imbrattacarte un’occhiataccia che non ammetteva repliche. Si era rivestito senza farsi la doccia e senza proferire verbo, si era infilato dritto nel pullman della squadra che li aveva portati all’Hilton, a un tiro di schioppo dall’arena.
Nessuno osava rivolgergli la parola. Era stato fortemente tentato dal noleggiare un taxi e farsi portare ad Atlantic City per passare la nottata sui tavoli, giusto per distrarsi. Poi però aveva deciso che non era cosa. Era meglio sparire per un po’. Per cui si era rintanato nella sua stanza d’albergo per sfogarsi con due dei suoi migliori amici, il signor Johnnie Walker e il colonnello Sanders. Ricordava solo di essersi scolato due bottiglie, forse tre, e di essere svenuto dopo il sesto petto di pollo fritto.
Finì di sciacquarsi, abbrancò un asciugamano e se lo avvolse attorno alla vita. Gocciolando dappertutto, si diresse verso la valigia, aprì un astuccio e riuscì a recuperare un paio di aspirine, che ingoiò intere. Si risedette sul letto e l’occhio gli cadde sul pager che mostrava due numeri da richiamare. Uno di Philadelphia. Era Maureen. Il secondo aveva un prefisso dell’Alabama. E lì capì di avere combinato un casino. Altro che Rod Thorn: in quel momento, Charles avrebbe preferito giocare a carte con Satana piuttosto che parlare con mamma Charcey.
Cazzo.
Rimase fermo, le braccia appoggiate sulle ginocchia, a fissare il vuoto per qualche interminabile secondo, senza pensare a niente. Quando si rese conto che qualcuno stava entrando nella suite, era troppo tardi e si trovò faccia a faccia con la signora Mabel.
“Ma che…”
“Oddio, mi scusi!” fece lei, imbarazzata dal trovarsi davanti un uomo seminudo.“Torni dopo”, rispose Charles secco.
“Mi dispiace, ma la sua è l’ultima stanza da fare. Non ci mettterò molto, le assicuro…”
“HO DETTO DOPO!” tuonò Barkley, sbattendole la porta in faccia.
La signora Mabel rimase immobile per un secondo. E poi, senza sapere neanche perché, cominciò a bussare. Una volta. Due. Tre. Finché quel tizio venne a riaprire. Era una specie di montagna che la guardava dall’alto in basso. Ed era decisamente poco amichevole.
“Parlo arabo o cosa?!!”
“Senta, ho solo bisogno di qualche minuto. Ho fatto tutto il piano, mi dia solo un attimo..”
“Cos’è, le servono degli occhiali? Non lo vede che sono mezzo nudo?”
SLAM.

La signora Mabel si ritrovò di nuovo a fissare la targhetta di metallo col numero della suite. Avrebbe potuto aspettare fino alla fine del turno e sbolognare quel maleducato, che tra l’altro aveva molto poco addosso, a qualcun altro. Ma non era nel suo stile. Il cliente avrà sempre ragione, ma da che mondo è mondo Mabel Eunice Jackson non era una da farsi mettere i piedi in testa da nessuno.
Ribussò. Sentì rimbombare passi sul pavimento, frammisti a frasi non esattamente da educanda. La porta si spalancò di colpo. La sagoma di quella sorta di orso occupava quasi tutto lo stipite.
“Ma allora non ci siamo capiti, eh! Ha perso anche l’apparecchio acustico per caso?!”
La signora Mabel fece un respiro profondo, sentendosi bruciare le narici. E sfoderò l’artiglieria pesante, come la chiamava suo marito Philmore ogni volta che litigavano.
“No, non ci siamo capiti, giovanotto” rispose calma, guardandolo dritto negli occhi.
“Lei potrà anche avere tutti i soldi del mondo, ma non si permetta di parlarmi così. Sono in piedi dalle cinque di stamattina, sono stanca e, a dirgliela tutta, sono troppo vecchia per venire trattata in questa maniera. Ne ho avuto abbastanza di bellimbusti come lei che pensano che noi cameriere non valiamo niente. Ma chi si crede di essere? Io vengo dall’Alabama, sa. Ho una morale e ho classe. Potrei anche essere sua madre. Si dia una calmata e visto che si è fatto una doccia, si lavi anche la bocca col sapone! Screanzato.”
E girò i tacchi, spingendo il carrello di servizio verso l’ascensore e lasciando Charles imbambolato.
Barkley rimase immobile come una statua per qualche secondo. Sembrava rincretinito e non badava al fatto che fosse praticamente nudo e bagnato fradicio. Dalla stanza di fronte uscì una coppia di quarantenni con un bambino di cinque anni, forse sei, che lo indicò con il dito ridacchiando.
Rientrò in camera arretrando, si chiuse dentro a doppia mandata e andò di nuovo a sedersi sul letto, sempre con quell’espressione ebete sul volto. Ma che diavolo era appena successo?
Senza sapere perché, si sentiva come se avesse visto un fantasma.
Era tanto che qualcuno non gli teneva testa così. Era tanto che non si trovava senza parole.
E poi quelle frasi. Quelle ultime frasi che continuavano a ronzargli in testa.
“Io vengo dall’Alabama, sa. Ho una morale e ho classe.”
“Si lavi la bocca col sapone.”
“Potrei anche essere sua madre.”
“Potrei essere sua madre.”
“Sua madre.”
Gli cadde di nuovo l’occhio sul pager e gli mancò improvvisamente il fiato. Alzatosi di colpo, cominciò a girare in tondo per la stanza finché non finì in bagno, appoggiandosi con tutto il corpo sul lavandino. Dovette fare uno sforzo immondo per sollevare la testa, ma si constrinse a guardarsi allo specchio.
Era vero. Quella donna poteva davvero essere sua madre. In un’altra vita, quella donna era stata sua madre. E lui, proprio lui tra tutte le persone di questo mondo, l’aveva trattata come una pezza da piedi.
Si sentì sopraffare dalla vergogna e, non riuscendo a sopportare neanche la propria faccia, andò a sprofondarsi nella poltrona di cuoio. Si prese altre due aspirine. Le tempie gli pulsavano a mille all’ora.
Come si chiamava? Come diavolo si chiamava? Fitzgerald. No, Fitzsimmons. No, non Fitzsimmons…Fitzgibbons. La signora Fitzgibbons. Era quella ricca bianca che aveva la casa in centro a Leeds, dall’altra parte della città. Lui e sua madre ci andavano ogni sabato mattina a fare le pulizie. Si era praticamente usurato le ginocchia su quel pavimento, a furia di tirarlo a lucido. E aveva strofinato quella vasca da bagno fino a piangere.
La signora Fitzgibbons li pagava anche bene, 2 dollari l’ora a testa, per spolverare la casa da cima a fondo e farla brillare come uno specchio. Le sembrava di sentirla mentre chiacchierava con le amiche, sorseggiando tè ghiacciato sotto il portico mentre lui e sua madre si spaccavano la schiena.
E la signora Fitzgibbons, grazie a Dio, non era la sola. Quanti ce n’erano – i Robinson, i Deveraux, i Maddox… Tutta gente che il piccolo Chuck visitava ogni giorno dopo la scuola per sprimacciare i cuscini, rifare i letti, lavare i piatti, stirare le camicie. Ore e ore passate a fare le faccende domestiche dai bianchi, con e senza sua mamma. D’altronde, non avevano un centesimo e lui era l’uomo di casa, visto che papà Frank era uscito per comprare il classico pacchetto di sigarette ed era finito, guardacaso, in California. In qualche modo bisognava pur mangiare.
Già, mangiare. Sembrava che in casa non ci fosse mai abbastanza. Lui e sua mamma lavoravano sempre. Sempre. Ma anche con l’aiuto di nonna Johnnie Mae, che faceva i turni alla fabbrica di carni e quando riusciva s’improvvisava estetista, non c’erano mai i soldi per dare alla dispensa un aspetto quantomeno dignitoso. Per cui, più spesso che no, la famiglia Barkley si teneva in piedi con i panini mortadella e formaggio rimediati grazie agli aiuti governativi. Che schifo che facevano, quei panini. Se li sognava pure di notte, anche adesso a distanza di vent’anni.
Osservò il faccione del colonnello Sanders che gli sorrideva dal secchio della KFC, grande quanto una piscina, che la faceva da padrone sul comodino.
Ma che ne sapeva la gente di cosa voleva dire avere fame?
Lui fame ce l’aveva sempre. Di quella fame ruggente, nervosa, che ti fa trangugiare la vita – denaro, basket, cibo, donne – senza neanche sentirne il sapore. Perché hai paura che possa finire. Perché hai paura di rimanere senza. Perché hai paura che da un giorno all’altro ti dicano che il sogno è finito, che il frigo è vuoto e che devi tornare a tirare avanti a panini mortadella e formaggio.
Lui non ci pensava proprio. Per cui, ogni occasione che aveva d’ingozzarsi la coglieva al volo. Pizze, hot dog, hamburger. Qualunque cosa. D’altronde, non sapeva da dove sarebbe arrivato il suo prossimo pasto e sprecare ogni briciola era un affronto a Dio.
Quella logica la applicava anche alla vita. Non tanto alla scuola, dove di confidenza coi libri non ne aveva mai avuta, ma sul campo da basket. Il suo biglietto per scappare alla povertà.
Il binomio basket-cibo lo aveva accompagnato da sempre. Sin da quando aveva raggiunto il quintale a 16 anni, alto neanche 1,78, e lo avevano tagliato dalla prima squadra. Ma era solo questione di tempo. E di lasciare che Madre Natura facesse il suo mestiere.
In un’estate era cresciuto di 15 centimetri. La musica era cambiata, e da senior si era conquistato un posto in quintetto, era il caso di dirlo, con le unghie e con i denti. Il mettersi a stecchetto non rientrava nelle sue priorità, però. Non aveva avuto bisogno di diete per stendere Bobby Lee Hurt, il miglior giocatore dell’Alabama, nelle semifinali del campionato statale. Era lì che uno degli assistenti allenatori di Auburn l’aveva notato e aveva scritto a coach Sonny Smith: “Ho appena visto un ciccione che gioca come il vento.” E in quel momento era cambiato tutto.
Gli anni successivi erano passati in fretta: i record coi Tigers con cifre pazzesche, la partecipazione al torneo NCAA, il tryout per la squadra delle Olimpiadi di LA dalle quali era stato tagliato.
Erano fioriti i soprannomi: The Love Boat; The Crisco Kid, un grasso vegetale che nonna Johnnie Mae usava preparare torte; e soprattutto, The Round Mound of Rebound. L’ammasso rotondo che prende rimbalzi. Aveva perfino fatto un servizio fotografico in cui si abboffava di pizza. Aveva adottato in pieno il personaggio, soprattutto perché non gli costava niente. A lui fregava poco di apparire bello o tirato a lucido: gli interessava vincere. Senza contare che non navigava nell’oro, anzi. Per cui, un pranzo gratis non si rifiutava mai.
Lui conosceva bene il suo corpo, lo sapeva come gestirsi tutti quegli stravizi. Sapeva fino a che limite spingersi, Come al Draft del 1984.
Si ritrovò a sorridere. Si ricordava ancora della chiamata del suo agente: “Chuck, i Sixers ti vogliono in squadra.”
Per un attimo gli era parso di toccare il cielo con un dito. Giocare con Dr J, Moses Malone e Mo Cheeks non era cosa da tutti. Era ricco, i giorni dei panini mortadella e formaggio erano finiti per lui e i suoi. Ma poi era arrivata la doccia fredda.
“Per ragioni salariali ti possono pagare solo 75.000 dollari a stagione.”
Come?! No way. Non aveva saltato la staccionata di casa a piedi uniti 2000 volte al giorno, preso e dato botte a bestioni più grossi di lui, non si era sacrificato tutti quegli anni per quattro soldi. Magari per altri era un salario rispettabile, ma lui sapeva di valere molto di più e non voleva svendersi. Tantopiù che aveva agenti e faccendieri da ripagare, gente che gli aveva permesso, sottobanco, di pagare le bollette di mamma Charcey e di togliersi qualche sfizio durante gli anni del college. Sì, era illegale, e allora? Doveva forse crepare di fame per un sistema idiota che non gli permetteva di lavorare mentre il rettore di Auburn faceva milioni con le sue partite? Insomma, quelli erano prestiti e voleva ripagarli, non gli piaceva essere in debito con nessuno. Per cui, 75.000 dollari l’anno non bastavano neanche lontanamente.
Sapeva di essere sovrappeso di un chiletto o due rispetto alle condizioni del contratto che Phila gli proponeva. Allora aveva guardato il suo agente con aria sorniona e aveva detto semplicemente: “Andiamo a mangiare un boccone.” In Pennsylvania non voleva finirci.
Di bocconi ne aveva mangiati, eccome. Due bistecche con patatine la sera, poi una doppia colazione da Denny’s (o iHop, forse, non ricordava bene, anche se la faccia della cameriera quando aveva ordinato “due di tutto” non se la sarebbe mai scordata) corredata da una torta intera, seguita da altri stuzzichini del genere a pranzo e cena. E aveva ripetuto il tutto il giorno dopo.
Quando era arrivato a New York per il Draft, era salito sulla bilancia e contemplato con soddisfazione i frutti del suo lavoro. Aveva preso 7 chili e passa in due giorni. Il proprietario dei Sixers era orripilato, ma l’aveva scelto lo stesso. E a stringere la mano a Rod Thorn Charles era salito con una faccia da funerale, oltre a un orrendo completo color vino che gli stava da schifo (e ovviamente stretto, dati gli exploit di cui sopra).
Aveva cercato di prenderla con filosofia e la sua, di filosofia, l’aveva portata anche nell’NBA. Aveva funzionato. Lui non si limitava a giocare con grinta: lui giocava con ferocia. Si avventava su ogni rimbalzo, stoppava ogni pallone, schiacciava come se volesse tirare giù il canestro. Ogni azione, ogni possesso. Ogni singolo movimento che faceva era un’esplosione di energia nervosa. Di fame, appunto.

L’unica cosa che era cambiata era, anche se limitatamente, la dieta.
Il buon Moses Malone, uno che con la forchetta aveva peraltro una certa confidenza, l’aveva preso da parte e gli aveva sussurrato che con un po’ di peso in meno addosso sarebbe diventato inarrestabile. Per una volta, aveva deciso di ascoltare, anche perché per lui, Moses era “Papà”. Era calato di 15 chili, aveva cominciato a lavorare sul suo gioco con Papà e con Dr J a fine carriera, aveva preso in mano le redini della squadra in men che non si dica, ammassando statistiche da capogiro e conquistandosi rapidamente un posto nei cuori dei tifosi. Erano arrivate le convocazioni per gli All-NBA teams, gli All-Star Games, i contratti di sponsorizzazione, i soldi. Insomma, il mondo era suo. E ce l’aveva fatta senza compromessi. Fregandosene del politically correct, sposando Maureen che era bianca per la disperazione della brava della gente dell’Alabama (tra cui, era sicuro, la signora Fitzgibbons), dicendolo chiaramente nelle interviste: non sono un role model, un esempio da seguire. Io gioco a basket. Fatemi fare il mio lavoro, litigare con arbitri e tifosi e lasciatemi in pace.
Stavolta, però, l’aveva fatta fuori dal vaso.
Si rialzò di nuovo, camminando su e giù per la stanza. Tornò a fissarsi nello specchio del bagno, costringendosi a guardarsi negli occhi.
Ma che diavolo stai facendo, si chiese. Sei ricco, famoso, giochi da Dio. Solo un mese fa hai vinto l’MVP dell’All-Star Game… Ma che ti salta in testa di sputare addosso a un imbecille, colpendo una ragazzina?
In quell’attimo, si rese conto di essere a un punto di svolta. Sapeva di non avere scuse e di dovere affrontare quella situazione. Sapeva anche di dover fare i conti con la rabbia che aveva dentro e che finora l’aveva aiutato a sopravvivere, a tirarsi fuori dal ghetto, a costruirsi una carriera e una vita che a gente come lui, il primo bambino nero nato nell’ospedale della bianchissima Leeds, era normalmente preclusa.
OK, Chuck, si disse. Con chi ce l’hai? Lascia perdere arbitri, tifosi idioti, giornalisti parassiti e tutti gli altri che girano intorno al carrozzone della tua vita, perché eri incazzato così anche prima dell’NBA. Con chi ce l’hai?
Con Leeds? Certo. Con i bianchi che ti hanno sempre trattato come inferiore e fatto fare a te e a tua madre una vita d’inferno? Ovvio. Con il coach che a scuola t’aveva tagliato dalla squadra della scuola? Sicuro. Ma era davvero tutto qui?
No .
Lui ce l’aveva con la signora Gomez. La signora Gomez che l’aveva bocciato all’esame di spagnolo tre volte e che lo sgridava sempre quando faceva il pagliaccio in classe o la spernacchiava, magari con frasi oscene recitate con l’accento di Speedy Gonzales. “Señor Barkley! Non mi interessa quant’è grosso: se non la smette, vengo lì e le lavo la bocca col sapone!”
Okay, la signora Gomez l’aveva costretto a ripetere quel maledetto esame, ma era davvero colpa sua? Quante volte aveva preso in mano i libri, davvero? Certo, era sempre troppo stanco per fare i compiti dopo una giornata passata al lavoro o in palestra, ma quella poveretta che ne sapeva? E soprattutto, che c’entrava?
Non c’entrava nulla, è vero. Anche se a causa dell’esame di spagnolo (be’, non solo di quello), si era diplomato tardi. Deludendo il suo vecchio.
Ah, il suo vecchio. Ecco qualcuno con cui ce l’aveva a morte. Perché se n’era andato, abbandonandoli tutti quando lui era piccolo e costringendoli di fatto a fare la fame. Almeno in quel caso, la sua rabbia era giustificata, no?
Sì, forse sì. Però il suo vecchio non gli aveva mai chiesto niente dopo che era diventato famoso. Non aveva fatto il parassita come tanti parenti o amici che riappaiono dal nulla non appena hai due soldi a tuo nome. E lui sapeva che non aveva un quattrino. Eppure, senza fare scenate o piangere miseria, aveva pagato di tasca sua il volo da LA ed era arrivato dalla California per la sua cerimonia di diploma. Che non aveva avuto luogo, proprio per via di quel famoso esame di spagnolo.
Il suo vecchio era stato uno stronzo, ma per quanto poteva continuare ad odiarlo?
Per quanto poteva continuare ad avercela col mondo e con la vita? Sapeva che prima o poi quel furore gli si sarebbe ritorto contro.
E forse era già successo.
Cacciò un sospiro enorme che sembrò rimpicciolirlo di qualche centimetro. Si riguardò negli occhi.
D’accordo, Charles Wade Barkley, sussurrò. Da oggi si cambia. Da oggi comincerai a rispettare il Gioco e il talento che ti è stato dato. Comincerai a fare il tuo lavoro per bene, a goderti la vita come si deve e smetterai di essere incazzato. Perdona la signora Gomez, perdona tuo padre e soprattutto perdona te stesso. E non dimenticarti mai più da dove vieni.
Fece silenzio e rimase fermo, fissandosi allo specchio per un minuto che sembrò non finire mai, suggellando quel patto con sé stesso. Sentiva solo il rumore della ventola del bagno.
Quando si sentì pronto, staccò le braccia dal lavandino. Si vestì rapidamente, scribacchiò una serie di nomi su un foglietto e poi abbrancò il telefono. Chiamò la reception, poi il suo agente. E per ultimo, digitò un prefisso dell’Alabama. Non c’era più tempo da perdere.
La signora Mabel chiuse dietro di sé la porta di servizio. Aveva bisogno di prendere un po’ d’aria. Era in pausa pranzo, anche se erano sì e no le 10 del mattino, e per ragioni tutte sue aveva meglio da fare che ascoltare i pettegolezzi delle colleghe.
Si stava mangiando le mani per le parole dette a quel tizio. Ma che le era preso? Non era la prima volta che la trattavano male. Avrebbe dovuto passarci sopra. Quello poteva farla licenziare. E Dio solo sa quanto aveva bisogno di quel lavoro. C’erano mille bollette da pagare e non si poteva certo permettere di restare disoccupata alla sua età.
Si diresse verso la Gertrude, aprì la portiera e si sedette sul sedile dalla parte del passeggero, i piedi appoggiati sul marciapiede. Accese la radio: sapeva di scaricare la batteria facendo così, e non aveva particolarmente voglia di farsela a piedi fino a casa, ma aveva bisogno di ascoltare un po’ di gospel. Magari anche un bel sermone.
“Ehm, signora? Mi scusi.”
La signora Mabel sollevò una palpebra. Poi l’altra. E riconobbe il tizio che qualche ora prima l’aveva presa a male parole. Come da copione, era talmente grosso da oscurare il sole.
“Ah, è lei.”
“Già, sono io.”
“Quasi non la riconoscevo con dei vestiti addosso. Sembra quasi una brava persona.”
Lui fece una risatina. “È vero, ma dicono che l’abito non fa il monaco.”
“Infatti. Be’, che vuole? È qui per dirmi che mi farà perdere il lavoro? Se è cosi, mi lasci almeno godere la mia ultima pausa pranzo.”
“No, no, signora. Tutt’altro.”
“In che senso?”
“Sono venuto a scusarmi per prima. Non avrei dovuto trattarla così, mi dispiace molto.”
“Mhm”, bofonchiò la signora Mabel. “Quindi non mi fa licenziare?”
“No, signora. Non ho detto niente a nessuno. Davvero, ero solo qui per chiederle scusa. Ho avuto una brutta nottata ed ero un po’ nervoso.”
“Un po’ nervoso?” fece lei, alzando le sopracciglia.
“OK, molto nervoso. Ma non avrei dovuto prendermela con lei.”
La signora Mabel lo squadrò dalla testa ai piedi come faceva con suo figlio Leroy quando ne combinava una delle sue.
“Ah, su questo può giurarci. Vuole raccontarmi che è successo?”
“Nah, niente. Problemi di lavoro. E anche lì, ho tirato in mezzo qualcuno che non c’entrava.”
“Ah, quindi è un vizio.” La signora Mabel si morse la lingua. Il tizio stava davvero provando a scusarsi, non aveva senso infierire. “È una cosa risolvibile?”
“Per il lavoro, certo. Non so bene come comportarmi con quell’altra persona, però.”
“Be’, provi a chiedere scusa come sta facendo con me. È un inizio.”
“D’accordo, grazie.”
Barkley le tese il braccio e per la prima volta sotto le occhiaie, si potè intravedere un sorriso.
“Ah però,” osservò la signora Mabel, stringendogli la mano. “Non è neanche tanto male quando sorride. Dovrebbe farlo più spesso, sa?”
“Ci proverò. Arrivederci.”
E salutandola con un cenno, si voltò e procedette in direzione dell’entrata principale. Fece appena in tempo a passare Latisha, l’ultima arrivata tra lo staff delle cameriere e la più giovane del gruppo, che gli fece un sorrisino imbarazzato.
“Mabel! Mabel!”
“Che c’è, Latisha?” fece Mabel. Latisha era la più pettegola di tutte e sicuramente non avrebbe tenuto la bocca chiusa se le avesse raccontato qualcosa.
“Ti stavo cercando dappertutto! Era venuto a cercarti nella sala caffè! Oh mio Dio!” continuò, gesticolando all’impazzata.
“Calmati Latisha, per l’amor del cielo!”
“Ma lo sai chi è quello?”
“No, non ne ho idea.”
“È Charles Barkley!”
“Chi?”
“Ma non la vedi la TV Mabel? Leroy non segue il basket?”
“No, gli piace il football, ma insomma mi vuoi dire chi è questo?”
“È un giocatore di pallacanestro, un campione. È su tutti i notiziari, è quello che ha sputato addosso alla bambina ieri.”
“Ma non mi dire!” rispose Mabel, scioccata.
“Te lo giuro! Ed è venuto a chiedere di te nella sala caffè. Eravamo tutte terrorizzate e non volevamo neanche parlarci ma ci ha salutate una per una e ci ha trattate da vero gentiluomo. Il signor Lomax dice che ci ha regalato delle uniformi nuove. In più ci ha dato dei biglietti per la prossima partita. E 100 dollari di mancia a tutto il personale dell’hotel!”
“Come sarebbe a dire, tutto il personale?”
“Tutto il personale! O meglio, tutti tranne te. Mi ha chiesto di farti avere questa.” E le allungò una busta.
“Per me?” chiese Mabel. Ma che accidenti poteva esserci lì dentro?
La busta conteneva un assegno con più zeri di quanti Mabel avesse mai visto in vita sua.
“Oh Signore benedetto!” Si dovette sedere per evitare di svenire.
La busta conteneva anche un foglietto con carta intestata dell’Hilton, scritto a mano.
“Signora, la prego di accettare le mie scuse per la maniera inqualificabile in cui mi sono comportato stamattina. In lei ho rivisto mia madre, che faceva il suo stesso lavoro e che spesso aiutavo dopo la scuola. Lei mi ha fatto ricordare chi sono e di questo le sono molto grato.
Con stima,
Charles Barkley”
PS – L’assegno non è un’elemosina, ma semplicemente un bonus per l’eccellente servizio da lei fornito in tutti questi anni. La camera era perfetta e il letto era fatto con un triple-sheeting da manuale. Un grazie a lei e a tutte le sue colleghe.”
In quel momento arrivò il signor Lomax. “Mabel, era tua la 1190?”
“Sì, perché?” chiese lei, aspettandosi l’inevitabile ramanzina. Chissà in che condizioni l’aveva lasciata quel tizio.
“Ah, non so cos’hai bevuto stamattina ma è tirata a lucido come il giorno dell’inaugurazione. Non c’è un bruscolo fuori posto. E il signor Barkley ci ha tenuto a farmi sapere che l’hai trattato con i guanti bianchi e che ci raccomanderà a tutti i suoi amici. Ti devo fare i miei complimenti, davvero un ottimo lavoro. Prenditi pure il resto della mattinata.”
OK, questo era decisamente troppo. La signora Mabel salì in macchina e chiuse la portiera. Era troppo intontita per guidare e accese la radio. La voce di Mahalia Jackson echeggiò all’interno della vecchia Oldsmobile. His eye is on the sparrow, cantava, e gli occhi della signora Mabel si riempirono di lacrime.
His eye is on the sparrow, and I know He watches over me.
Amen, Signore, amen.