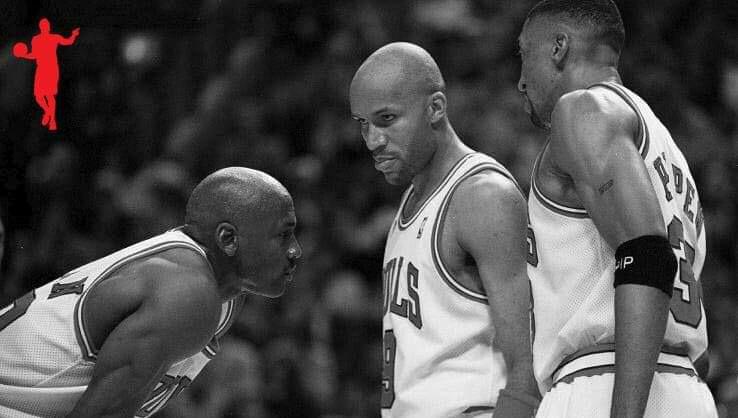Una rassegna delle signature moves più importanti della storia della NBA: alcune impossibili da imitare, altre diventate veri e propri fondamentali insegnati in ogni scuola basket del pianeta.

Nell’arte capita spesso: gesti, linee, parole, forme che rimandino in modo istantaneo al loro creatore, che attraverso esse esprime tutta la sua personalità.
Nella musica talvolta basta una singola nota o un singolo suono per attribuire la paternità di un brano a questo o quell’artista.
Ancor più evidente nelle arti figurative, dove il tratto peculiare di un pittore o di uno scultore sono spesso così evidenti da permettere anche a dei non esperti di riconoscere l’autore di un’opera.
I più attenti possono notarlo anche al cinema, riconoscendo il regista del film da una particolare composizione di un’inquadratura o un determinato movimento di macchina.
A questo punto la metafora direi che è abbastanza chiara: se è vero che il basket è poesia in movimento, il parallelo calza alla perfezione. Non c’è alcuna differenza tra l’uso dei colori di Van Gogh, la chitarra di Jimi Hendrix o i close-up di Sergio Leone e alcune storiche signature moves della storia della NBA – che prendiamo in rassegna qui di seguito – azioni che anche se vedessimo compiute da un manichino stile crash test potremmo subito attribuire all’autore originale.
Tra gesti impossibili da imitare, legati indissolubilmente ai loro creatori, e altri entrati nel bagaglio universale di ogni giocatore sul pianeta, abbiamo scelto i seguenti.
SKYHOOK – Kareem Adbul-Jabbar
Quella che Pat Riley ha definito come l’arma più devastante della storia della pallacanestro è sicuramente una delle maggiori vie con cui Jabbar è arrivato a segnare i suoi 38387 punti, proiettandolo in cima – virtualmente irraggiungibile – alla classifica dei marcatori nella storia della Lega.
Il Gancio Cielo – all rights reserved – è un’evoluzione pressoché inarrestabile del comune gancio, un fondamentale le cui origini vengono poste dagli storici agli Europei del 1937, più precisamente per merito del lituano-americano Pranas Talzūnas, che con i baltici vinse la medaglia d’oro in quella manifestazione.
Dopo che il Globetrotter Goose Tatum ne fece un marchio di fabbrica e Mikan lo portò tra i professionisti con regolarità, fu l’allora Alcindor a perfezionarlo, favorito dalla sua infinita lunghezza. Un 2.18 che allunga il braccio verso il firmamento e fa partire una parabola quasi discendente verso il canestro è praticamente inarrestabile: su milioni di tentativi le stoppate ricevute si contano sulle dita di mezza mano. Il termine venne coniato da Eddie Doucette, allora commentatore dei Milwaukee Bucks, ispirato dall’altissima parabola del tiro del futuro Kareem, che portava il pallone “così in alto da sembrare che arrivasse dal cielo”.
Tutti i centri, dopo Jabbar, hanno cercato di sviluppare una simile sensibilità nei confronti del gancio con risultati alterni: nessuno come Kareem è riuscito a farlo suo e mandarlo a segno con continuità.
FINGER ROLL – George Gervin
Sono i grandi centri degli anni ’60 a portare in NBA una sorta di antenato del finger roll: Chamberlain e Russell solevano far rotolare la palla dalle loro lunghe e affusolate falangi nel canestro.
Partendo già da altezze siderali si trattava più di lasciar cadere il pallone dentro al ferro: la forma definitiva del finger roll, una delle giocate più di classe mai viste sui campi di basket a ogni latitudine, viene plasmata da George Gervin. Nella sua interpretazione, consiste nel lasciar scivolare delicatamente il pallone lungo le dita, dandogli una spinta finale con la punta dei polpastrelli, alzando la parabola quel tanto che basti ad evitare interventi dei difensori. “La gente dice sempre che l’ho inventato, ma non posso accettarlo: ho semplicemente avuto l’intelligenza di osservare Wilt, Dr. J e Connie Hawkins farlo prima di me, vedere quanto potesse essere efficace e farlo mio, personalizzandolo”.
Gervin si specializzò a tal punto da poter concludere in questa maniera dalla linea del tiro libero o da dietro al tabellone, legando per sempre la sua figura a questa abilità.
L’avvento di atleti sempre più straordinari ha fatto cadere in disuso l’uso del finger roll a favore, il più possibile, del tentativo di schiacciare, cercando di aumentare la percentuale di successo.
Più avanti vedremo però come, in tempi più recenti, sia nato un fondamentale che trae sicura ispirazione da questa elegante conclusione.
DREAM SHAKE – Hakeem Olajuwon
L’enciclopedia di movimenti offensivi del nigeriano è un volume che andrebbe tradotto in tutte le lingue del mondo e assegnato come testo scolastico a tutti i lunghi del pianeta – in parte è già così.
Ha ancora del misterioso come abbia fatto The Dream a toccare una palla da basket per la prima volta a 17 anni e in pochissimo tempo diventare uno dei centri simbolo del Gioco, fonte d’ispirazione per tutti i posteri.
Ogni simbolo ha diritto a una giocata simbolo: per Olajuwon, quella giocata è senza dubbio il Dream Shake.
Conditio sine qua non: avere grande mobilità di piedi e agilità, oltre a un discreto QI cestistico, che permetta di leggere i movimenti del difensore. Hakeem cercava di ricevere il pallone in post basso, spalle a canestro, con entrambi i piedi ben piantati per terra, in modo da poter scegliere il perno e non dare quindi punti di riferimento all’avversario. A quel punto iniziava un esaltante balletto di finte, con la testa, con le spalle, al quale il difensore doveva prestare la massima attenzione: se gli si stava troppo attaccato, facendo sentire il proprio corpo, The Dream, con velocità disarmante, partiva in palleggio con una virata da guardia, involandosi verso il canestro.
Si voleva evitare questo imbarazzo, lasciandogli più spazio? La classica coperta corta, perché il jumper dalla media del nigeriano meritava ogni sorta di rispetto. Ad oggi, risulta ancora uno dei movimenti più difficili da marcare in post basso nella storia della pallacanestro.
FADEAWAY – Michael Jordan, Dirk Nowitzki
Se parliamo di marchi di fabbrica, His Airness è uno di quelli ad aver depositato il maggior numero di brevetti.
Tra schiacciate innovative, cambi di mano in aria e layup in reverse, l’attenzione non può però che ricadere sul suo iconico fadeaway jumper.
Nato in situazioni d’isolamento, la maggior parte delle volte consisteva nel ricevere la spicchia spalle a canestro, “sentire” il difensore, disorientarlo con una finta di spalle prima di girarsi e tirare in sospensione, con un salto all’indietro.
Le fredde parole non riescono a descrivere la bellezza di un movimento che Michael ha interiorizzato a tal punto da arrivare a trasformarlo nell’82% dei casi negli ultimi due anni di carriera, in quel di Washington.
La separazione creata dal salto all’indietro rende virtualmente impossibile ostacolarlo: poi ci sarebbe il dettaglio di segnare in condizioni di equilibrio precario, lì entra in gioco il talento incalcolabile del 23.
Impossibile non notare come Kobe lo abbia studiato e ristudiato, pedissequamente, fino a farne una sua arma per eccellenza.
In tempi più recenti, Dirk Nowitzki ha rivoluzionato il fadeaway, rendendolo un’arma ancor più letale.
La leggenda vuole che Rick Carlisle, appena insediatosi sulla panchina dei Mavs nel 2008, abbia chiesto a Dirk di cercare una nuova soluzione offensiva, che il tedesco potesse essere in grado di sfruttare sempre, in ogni situazione e contro ogni potenziale avversario.
L’etica del lavoro di WunderDirk è cosa nota: chiusosi in palestra con Geschwindner, cerca di assimilare il Dream Shake di cui sopra, con – pare – pessimi risultati. Così decise di concentrarsi su quello che lui stesso ha definito “la versione bianca del Dream Shake”.
Allenamento dopo allenamento, nasce quel suo strano fadeaway su una gamba sola – saltando pochissimo – in cui Nowitzki si allontana dal difensore, inarcandosi in modo esagerato con la schiena, creando così una separazione incolmabile, che unita alla sua clamorosa sensibilità nei polpastrelli, ne fa un’arma formidabile.
Arma chiave della seconda parte della sua carriera, longeva e piena di successi.
CROSSOVER – Tim Hardaway, Allen Iverson, Jamal Crawford
Di base il crossover è molto semplice: consiste nel dare l’impressione al difensore di andare in una direzione per poi, improvvisamente, cambiare tale direzione, con un destabilizzante palleggio incrociato. È un fondamentale base della pallacanestro, ma le point guard degli ultimi 30 anni hanno aggiunto ognuna qualcosa di speciale a quello che in origine era un comune cambio di rotta e mano, rendendo il crossover sempre più letale, fino a generare il grande filone epico dell’ankle breaker.
Uno dei primi artisti del gesto è il figlio di Brooklyn Dwayne “Pearl” Washington, che a metà degli anni ’80 entusiasmava i tifosi di Syracuse University e tormentava gli avversari, con questi cambi di direzione a velocità estrema, mantenendo un palleggio con baricentro bassissimo che raramente si era visto prima. Il primo a raccogliere il testimone del crossover e portarlo un po’ più in là è Tim Hardaway, con il suo cosiddetto UTEP 2 Step: sviluppato durante il suo periodo all’università di Texas El Paso, Tim aggiunge un palleggio in mezzo alle gambe prima del cambio di direzione. La forza e la velocità con cui effettua questa mossa fanno risuonare due esplosioni nelle orecchie di chiunque osservi quei due palleggi: BOOM-BOOM, e il difensore è fregato.
Altro custode dei segreti del crossover è sicuramente Allen Iverson e anche per lui tutto cambia all’università, presso Georgetown. Uno dei suoi compagni è Dean Berry, walk-on player nato e cresciuto a Brooklyn nel mito di Dwayne Washington.
Berry, imparando dal suo idolo, è un maestro del crossover, tanto da mettere in imbarazzo il suo ben più quotato compagno ad ogni singolo allenamento.
“Ci cascavo sempre: sapevo che stava per farmelo, mi preparavo mentalmente e fisicamente, eppure mi fregava ogni volta. Ero troppo orgoglioso per chiedergli come faceva…ma a un certo punto ho trovato la forza e ci siamo fermati dopo un allenamento e me l’ha mostrato. Così ho iniziato a farlo anch’io”.
Il tratto distintivo del crossover di Iverson è l’hesitation con le spalle, che aggiunta alla sua irreale velocità e agilità diventa un incubo per i difensori: anche i migliori specialisti della questione sono finiti col “culo per terra” a causa di un palleggio incrociato del numero 3.
In tempi ancor più recenti, impossibile non citare Jamal Crawford, che ha rivoluzionato ancora il crossover con una sua versione personalissima e molto spettacolare: lo Shake and Bake.
Con un palleggio dietro la schiena invita il difensore a credere che andrà da un lato, ma con la mano di richiamo si ripassa il pallone nella mano che ha effettuato il primo palleggio e inizia il terzo tempo, con conseguente comodo layup, visto che l’avversario è ancora in stato confusionale.
(ndr: Shammgod è stato omesso solo perché ne avevamo già parlato in questo articolo)
BANK SHOT – Tim Duncan
Non l’hanno soprannominato The Big Fundamental per caso: la signature move di Tim Duncan è una delle cose più semplici, meno spettacolari ma più efficaci mai vista nella NBA ad altissimi livelli. Il suo tiro usando il tabellone è la summa di quel che ha rappresentato nel panorama cestistico: un custode della sacralità del Gioco, in un’era di nuove scintillanti superstar alla costante ricerca del suscitare stupore. Cosa hanno insegnato a ognuno di noi quando eravamo al minibasket? Quando si è vicino al canestro, da un lato o dall’altro, bisogna usare l’amico tabellone per aumentare le possibilità di successo del nostro tiro. Duncan ha portato questo concetto al livello più alto possibile: fronteggiava il canestro e l’avversario e in men che non si dica si era alzato per due punti appoggiati al vetro. Oppure riceveva spalle a canestro e si girava per concludere a una mano, sia da destra che da sinistra, sempre appoggiando il pallone alla tabella. Come per altre grandi signature moves, tutti sanno che sta per succedere ma non c’è modo di fermarla, data anche l’altezza da cui partono le conclusioni del 21.
Ma allora perché non lo vediamo più cosi spesso? Perché un tiro così semplice eppure così efficace non viene usato con continuità da altre ali forti o centri in attività? “Perché non è cool”, sostiene Popovich...
FLOATER – Juan Carlos Navarro, Tony Parker
Un derivato del finger roll, il floater (o runner, o teardrop) è una valida opzione per tutti i piccoli del mondo che si trovino involati verso il canestro, con dei bestioni di oltre 2 metri pronti a spedire la loro conclusione verso il secondo anello del palazzo. Come? Lasciando andare il pallone con una parabola più alta del normale, trasformando la spicchia in un petalo di fiore, che si libra sopra le braccia tese dei difensori per poi adagiarsi delicatamente nella retina.
Nonostante sia ormai nel bagaglio di molti, è un tiro tutt’altro che semplice, che richiede una sensibilità non alla portata di tutti.
Le origini sono incerte e dopo decenni di discussioni non è ancora chiaro se fu Hank Luisetti in quel di Stanford o Bob Cousy in quel di Boston a usare questo tiro in corsa a una mano per la prima volta. In tempi più recenti sono tanti i giocatori che ne hanno fatto un’arma efficace, ma non si può non partire da Juan Carlos Navarro. Il catalano è stato un vero e proprio artista della lacrima, tanto da essere lui stesso soprannominato “La Bomba”, il nome che gli spagnoli hanno dato al tiro. Sempre di aria FIBA, poi diventata una leggenda oltreoceano, è Tony Parker che scherzosamente ha sempre sostenuto di detenere il copyright del floater.
Come Navarro, il francese ha spesso usato questa conclusione anche per anticipare il difensore, alzandosi magari in un secondo tempo, lasciando andare il pallone ancora con i piedi per terra o appena in fase di salto.
Parallelamente, negli States, grandi guardie come Mark Jackson, John Stockton o Gary Payton lo eseguivano con una certa continuità, fino a trasmetterlo, in tempi più recenti a Steph Curry, che negli ultimi anni è sicuramente il giocatore a cui si è visto ricorrere più spesso, e con grandi percentuali, al floater.
EUROSTEP – Emmanuel Ginobili
Come il nome stesso suggerisce, è il vecchio continente a dare i natali alla prossima signature move. In NBA, quando cominciò a diffondersi l’uso di questo terzo tempo “rallentato”, con due passi in due direzioni diverse, ci fu una sorta di shock culturale: gli arbitri non erano pronti e spesso fischiavano infrazioni di passi inesistenti. Con l’abitudine e soprattutto grazie a Ginobili, che l’ha sempre adottato con continuità, l’eurostep è entrato nel bagaglio anche dei giocatori americani (chiedere al Barba, a Westbrook o Dwyane Wade).
L’origine è in terra balcanica, Serbia per l’esattezza, e sembra che risalga agli anni ’60 grazie alla leggenda della Stella Rossa Vladimir Cvetković. Dopo di lui, in tutte le scuole basket della ex Jugoslavia i giocatori sono cresciuti imparando questo fondamentale.
“Ci avevano spiegato che potevi fare due passi nel terzo tempo, non importava che fossero in avanti, a zigzag, uno avanti uno indietro, era la stessa cosa. Finché erano due, avevamo il regolamento dalla nostra”.
– Toni Kukoc
I primi a esportarlo in America sono Petrovic e Marciulonis, anche se continua ad esserci diffidenza riguardo alla regolarità o meno del movimento. Ma il termine Eurostep compare per la prima volta nel 2007, in un articolo legato alla figura di Manu, che appena sbarcato da Bologna nella NBA ne ha fatto un fedele alleato. “Ero sconvolto quando la gente ha cominciato a parlarne, era la cosa più normale del mondo. Per me si trattava di pura sopravvivenza, cercare di evitare gente come Shaq o Karl Malone così da non farmi male”.
Harden ha sempre detto di essersi ispirato a Ginobili nell’esecuzione del suo terzo tempo rallentato e Antetokounmpo, grazie alle sue leve infinite, può iniziarlo dalla linea del tiro da tre: il futuro dell’Eurostep è nelle loro mani.
STEP BACK – Stephen Curry, James Harden
Sempre nel campo del creare separazione, lo step back è in assoluto il tiro che più di ogni altro ha preso piede negli anni recenti.
Secondo il leggendario Pete Newell, uno dei primi ad avvalersene fu Kiki Vandeweghe, mentre altri lo attribuiscono ad Archie Clark, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70.
È innegabile però che da quando è irrotto sulla scena Stephen Curry, lo step back abbia assunto un valore diverso, che sarà per sempre legato al nome suo e di altri talenti della sua generazione. È diventato quasi un must per le guardie di tutta la Lega, un modo per creare spazio tra sé e il difensore per un tiro che fornisce più equilibrio rispetto al fadeway di cui sopra.
Insieme a Curry, grandi esponenti sono Harden – le bacheche dei siti NBA sono piene di commenti che si chiedano se il suo step back sia passi o meno – Lillard, Irving, Doncic e molti altri, anche giocatori di taglie nettamente superiori. La cosa che sconvolge è la velocità travolgente con cui lo step back sia passato da essere una giocata extra-ordinaria a una mera routine, di pari passo con l’evoluzione del gioco, che galoppa incessantemente verso un futuro di assenza totale di ruoli e in cui tutti sapranno fare quasi tutto, dal tiro da tre, a crearsi una conclusione dal palleggio.