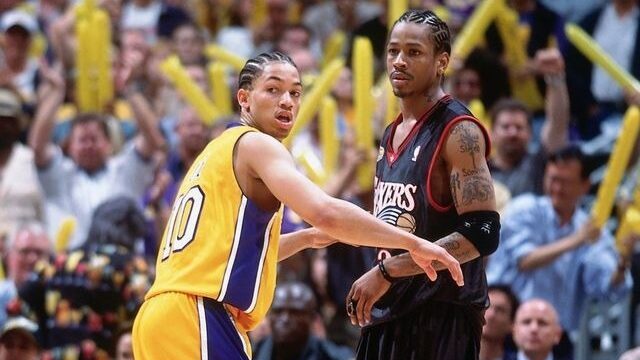La vicenda di Pop Gates, uno dei pionieri della pallacanestro afroamericana, per ricordare nel Black History Month le origini e le difficoltà del passato.

Difficilmente nell’immaginario comune europeo si ha una chiara idea dell’America degli Anni Venti che si distanzi minimamente dalle paillettes à la Great Gatsby o al brusco risveglio del Martedì Nero di Wall Street.
Entrambe le visioni, veicolate nel Vecchio Continente da degli States già vittoriosi del secondo conflitto mondiale ed in rampa di lancio per diventare paese-guida dell’Occidente come lo conosciamo oggi, sono in realtà clamorosamente fallate, proprio per l’immagine festaiola ed etnicamente integrata che si fornisce di un paese dove le discriminazioni non facevano che aumentare.
Se le scene di cantanti di night afroamericane, di Jazz e di drink a fiumi in un edonismo sfrenato sono di per sé reali, vanno tuttavia contestualizzate. Il furore che era seguito alla Grande Guerra era di per sé una posa se non altro stilistica, volta a dimenticare gli orrori e la fame degli anni precedenti e a ripartire ed imporsi come guida economica ad un’Europa decimata da caduti, malati ed immigrati proprio verso gli USA. Al contempo, i locali dove si potevano trovare momenti di integrazione e di svago erano di per sé illegali; il proibizionismo era qualcosa di tremendamente reale, le controparti concrete di Kevin Costner e soci non avevano ancora arrestato Al Capone, e comunque gli afroamericani impegnati nei locali erano visti come poco più che quei fenomeni da baraccone che tanto suscitavano il gusto dell’epoca.
Non tutto il male, per quanto viscerale e tremendo, come in questo caso, viene tuttavia per nuocere. Sebbene l’integrazione fosse unicamente parziale e circoscritta ad ambiti ben delineati, infatti, il mondo afroamericano coglierà fin da subito gli stimoli e le novità dei Roaring Twenties, mostrando fin da subito, con il boost del decisivo contributo in guerra della comunità, il proprio nuovo volto di integrazione e ricerca della parità di diritti.
Una mescolanza oggi spesso criticata, perché fatta copiando e stando all’interno delle regole dei bianchi, ma che presenta al proprio interno delle conquiste fondamentali che forniscono la base per i grandi leader che nei secoli successivi guideranno il movimento per i diritti civili.
Centro di questa fiorente fase culturale è sicuramente Harlem, nel distretto di Manhattan, centro di quell’Harlem Renaissance che rappresenterà la base del fermento culturale di quel decennio. Proprio in questo quartiere, pochi decenni prima di un altro grande eroe dello sport americano come Kareem Abdul-Jabbar, cresce uno dei pionieri dello sport e dell’integrazione: William “Pop” Gates.
Le Origini: dall’Alabama alla Grande Mela
La storia di William Penn Gates, noto oggi come Pop, è una storia emblematica dell’America di quegli anni. William nasce infatti nel 1917 in Alabama. Solamente sessant’anni prima il suo destino sarebbe stato quello di un uomo non libero e costretto nelle sterminate distese di cotone dello stato, ma la famiglia, stanca dopo generazioni di soprusi, decide di sfruttare la neoacquisita libertà e trasferirsi prima nel Northeast Ohio – dove comunque si respira un clima di violenza simile a quello che ancora travolge l’Alabama – ed in seguito nella più liberal New York, luogo in cui le opportunità, anche lavorative, per gli afroamericani sembrano essere molte di più.
In quella Harlem di cui abbiamo cercato di raccontare nell’introduzione, William entra in contatto con quello che sarà il grande amore della sua vita, la pallacanestro. Si distingue fin da subito, infatti, come giocatore di assoluto talento nei campetti della 132nd e della YMCA locale, stupendo i compagni di scuola anche in una delle discipline più newyorchesi che possiate incontrare: lo stickball, la variante di strada del baseball che si vede in film di culto come A Bronx Tale.
Proprio sul “Diamante” nasce anche il soprannome che lo accompagnerà per tutta la vita, come ricorda lo stesso Gates in un’intervista al New York Times datata 1988
“Giocavo sempre con i ragazzi più grandi, ed il gruppo della mia età ha iniziato a chiamarmi Pop, perché sembravo qualche anno più vecchio.”
Terminate le grade schools, Pop diventa, nonostante i suoi 21 anni dovuti a qualche bocciatura di troppo, stella della Benjamin Franklin High School, uno dei pochissimi licei integrati della City. Sotto la guida di coach Doc Spiegelman, Franklin vincerà il torneo cittadino del 1938, e Pop troverà l’interesse di diversi college per soli neri.
Tra questi, il più attivo è sicuramente il Clark College, di Atlanta, Georgia. Si tratta di un istituto di istruzione superiore metodista creato alla fine dell’Ottocento all’unico scopo di educare i freedmen, gli schiavi liberati. Un luogo dall’aura quasi sacrale per gli afroamericani di tutti i tempi proprio perché tra i primi centri pensati esclusivamente per la perpetrazione di cultura e storia della comunità e per colmare il gap educativo e culturale che secoli di atroce schiavitù avevano creato.
L’idillio sembra quindi perfetto: giocatore iconico della Harlem integrata, simbolo del nuovo corso dei ruggenti Anni Venti, che si iscrive nella scuola che più di ogni altra rappresenta invece la storia e le radici. Non si può, tuttavia, pensare di togliere un’oasi culturale dal suo contesto desertico. Il Clark College si trova, nonostante i propri nobili intenti, in uno degli stati più segregati – e segregazionisti – dell’Unione. Il Partito Democratico, egemone in quelle zone e nel paese con la politica roosveltiana, basa il proprio consenso elettorale nel Sud unicamente sui proprietari terrieri e i magnati, escludendo sistematicamente la popolazione di colore da qualsivoglia forma di attivismo – per non parlare delle Jim Crow Laws, volte ad impedire l’esercizio del diritto di voto. Le costrizioni ambientali sono tali da costringere William ad un quantomai precoce rientro nella Grande Mela.
“Non mi piacevano le barriere ed i pregiudizi di quel posto.”
Professionismo: Renaissance Era
La sua fama di giocatore, tuttavia, non è rimasta intaccata dai mesi lontano da casa. Appena rientrato, Pop trova subito un ingaggio negli Harlem Yankees, squadra del borough che fungeva spesso da sparring partner per gli allenamenti dei mitologici New York Renaissance.

Dobbiamo forzatamene, per quanto non sia mai una scelta conveniente, fermare la nostra narrazione per spiegare quale sia l’impatto della squadra di cui stiamo parlando. I Renaissance, noti informalmente come Harlem Rens, simbolo del tentativo di appropriazione del quartiere, sono una delle primissime squadre composte unicamente da afroamericani mai messe in piedi agli inizi del Novecento. Fondati nel 1923 dall’imprenditore nero Robert “Bob” Douglas e chiamati così in onore del Renaissance Casino, che faceva loro da palazzetto per le partite casalinghe, i Rens assursero alla fama a livello nazionale per le “amichevoli” giocate contro squadre delle leghe “bianche”.
Partite interraziali – già di per sé una rarità che attirava folle oceaniche per la pallacanestro dell’epoca – che terminavano con punteggi al limite dell’umiliante per gli avversari, tanto che si conta una streak vincente di 88 partite consecutive.
In un mondo del basket che, al pari degli altri sport professionistici e semi-professionistici, bandiva la presenza di giocatori di colore (la ABL, una delle lege più note del tempo, aveva addirittura una regola esplicitata contro l’utilizzo di afroamericani), i Rens fornivano un motivo d’orgoglio al quartiere e al mondo afroamericano in quello che già allora era sentito come il loro gioco, mostrando lapalissianamente la stupidità della segregazione sportiva e non.
Non è un caso che, se doveste chiedere all’harlemiano Kareem o a qualunque membro degli altrettanto harlemiani Globetrotters da dove venga la loro ispirazione, entrambi vi risponderebbero serenamente dai Renaissance.
Pop, quindi, si trova di fronte idoli della sua gioventù come Willie “Wee” Smith o Charles Cooper, centro soprannominato “Tarzan” per la sua fisicità ed altezza prodigiosa (oggi giocherebbe se va bene da guardia tiratrice, segno dei tempi che corrono). Dopo pochi allenamenti, tuttavia, è la franchigia ad interessarsi lui, offrendogli un ingaggio per la stagione 1938/1939
“Devono aver apprezzato quanto hanno visto, mi hanno offerto 100 dollari per comprarmi.”
Pochi mesi dopo quel fortunato “acquisto”, Gates si ritrova involontariamente al centro di una delle svolte storiche della pallacanestro americana o forse mondiale. Nel marzo del 1939, infatti, il Chicago Herald decide di creare un torneo ad inviti volto a riunificare le migliori squadre del tempo – sia tra leghe semi-pro che tra i gruppi itineranti come Rens e Globetrotters – in modo da decidere quale fosse la squadra campione del mondo.
Gates è quindi nel quintetto dei Reinassance che affronta – e vince – il World Professional Basketball Tournament del 1939. In Finale, giocata davanti ai 3000 paganti del Chicago Coliseum il 28 marzo, si renderà addirittura protagonista di una prestazione epica, segnando il 35% dei punti totali della sua squadra: ben 12 (sì, DODICI) su 34, un chiaro sintomo della bontà dei 24 secondi.
Gli anni successivi la squadra risente di alcuni cambiamenti di organico, dovuti anche ad un intervento militare diretto degli USA che si fa sempre più vicino. Nel 1940, i Renaissance perdono di misura, 37-36, il “derby” contro degli Harlem Globetrotters in decisa ascesa, anche economica, ed in grado di acquistare i migliori prospetti dei campetti del quartiere. Nell’anno successivo, 1941, si classificano invece terzi, vincendo la finalina contro i Toledo White Huts, squadra integrata che di lì a poco entrerà in una delle prime leghe pro, la National Basketball League.
La finalina, seguita da 12.000 spettatori paganti, quattro volte quelli della prima finale, vede tuttavia un Gates in ombra, con un solo canestro e quattro falli, come diligentemente riportato dai giornali dell’epoca. Gates è da considerarsi ormai a tutti gli effetti una stella a livello nazionale, tanto che una sua non-prestazione fa ormai notizia al pari di quella di un All-Star dei giorni nostri.
Gli anni della guerra: dai cambi continui alla NBL
Gli anni successivi al 1941, e quindi a quell’attacco di Pearl Harbor che il 7 dicembre aveva trascinato gli States in guerra, sono di difficile ricostruzione con le fonti in nostro possesso. Pop continua con ogni probabilità a giocare e svolgere tournee con i Rens fino al 1946, ma, quando le difficoltà economiche dovute al conflitto si fanno eccessive, non disdegna anche passare ad altre squadre.
Con alcuni compagni dei Rens, per esempio, aiuta i Washington Bears a conquistare il primo World Chapionship nel 1943 – venendo contestualmente nominato nel primo quintetto della competizione. Conscio che il settore militare sia ormai l’unico a smuovere l’economia, poi, Pop partecipa nei medesimi anni a diverse esibizioni con i Long Island Grumman Flyers, franchigia associata all’omonima fabbrica di velivoli da battaglia della Grande Mela.
Al termine del conflitto, poi, le cose non sembrano migliorare. Per tutto il biennio 1945-46, Gates si barcamena tra diverse squadre di medio livello leggendo sui giornali paragoni imbarazzanti nel merito e offensivi nella forma come quello che lo vede definito “l’Hank Satchel nero” (sostituite la parola edulcorata con un epiteto Anni Quaranta) oppure “il mago nero paragonato ad Hank Luisetti.”
La svolta, tuttavia, arriva di lì a poco. La NBL, in continua espansione a discapito della BAA – con cui darà vita alla Lega che oggi non ci dispiace guardare – sta definitivamente comprendendo come l’integrazione sia fondamentale per alzare il livello delle proprie franchigie e, conseguentemente, il numero dei paganti. Tra i proprietari più attivi in questo senso c’è sicuramente Leo Ferris, fondatore dei Buffalo Bisons e, successivamente, figura-chiave della prima stagione della NBA. Ferris, scontento dell’affluenza a Buffalo, decide nell’ottobre del 1946 di portare nello stato di New York il giocatore più acclamato dell’epoca, Pop. Quell’offseason, quindi, Gates – insieme ad altri tre giocatori afroamericani – diventa il primo giocatore di colore a firmare un contratto per una franchigia professionistica americana. Gli almanacchi, tuttavia, per via dei regolamenti sul professionismo ancora poco definiti, eleggeranno a pioniere in questo senso il giocatore di baseball Jackie Robinson, firmato dagli allora Brooklyn Dodgers sette mesi dopo William e gli altri. Certamente entrare in quello che allora era definito il National Pastime è tutt’altra cosa rispetto ad una NBL in crescita ma non ancora nei cuori degli appassionati, tuttavia ad aprire la strada è stata, come spesso in quest’ambito, la palla a spicchi.
“Quando Leo Ferris è venuto da me mi è sembrata una benedizione dal cielo.”
La stagione dei Bisons comincia, tuttavia, nel segno dell’incertezza; dopo solamente due mesi dall’ingaggio di Pop, Ferris, ormai stufo dell’accoglienza tiepida di Buffalo, decide di spostare la squadra a Moline, Illinois, rinominandola Tri-City Blackhawks (per uno scherzo del destino, gli Hawks di quell’Atlanta detestata da Gates ai tempi del college sono diretti discendenti della franchigia rilocata da Ferris).
Anche sul campo le cose non sembrano andare per il meglio. La squadra, che aveva chiuso con un record negativo la permanenza a Buffalo, mantiene un record sempre mediocre anche nel periodo a Moline, non mostrando miglioramenti. Il 20 febbraio, tuttavia, si giocano una delle ultime chances ai Playoffs contro i Syracuse Nationals. Gates, autore di una stagione anonima che chiuderà da terzo marcatore della squadra (7.6 PPG), entra nella partita dalla Palla a Due, iniziando fin da subito a mostrare il proprio purissimo talento a discapito di John “Chick” Meehan, idolo locale e stella dei Nats.

Meehan è tutto quello che ci si può aspettare da una guardia caucasica del New England degli Anni Quaranta: ruvido, pugnace, efficace anche a costo di piegare – o strappare – il regolamento. I canestri di Pop non lo scompongono eccessivamente, ma lo costringono ad un paio di scorrettezze e atterramenti rugbistici che alzano sensibilmente la tensione sul campo di gioco.
Verso la fine dei tempi regolamentari di una partita tiratissima, il fattaccio: Gates e controparte si avventano su una palla vagante, il newyorchese arriva in anticipo, mandando il siracusano per aria con un colpo perfettamente all’interno dei crismi del regolamento. La stella dei Nationals allora si alza, stordita, e si avvicina minacciosa all’avversario, il quale, habitué di certi pick-up games poco formali, decide di non fermarsi a chiedere spiegazioni stendendo Meehan con un destro prima che questi possa fare altrettanto.
A Syracuse è la rivolta, senza mezzi termini. Gates deve uscire scortato dalla National Guard per evitare il linciaggio con Meehan ancora privo di conoscenza e la partita non riprende per diversi minuti. Nello sport di quegli anni sembra difficile credere che una rissa da campo abbia suscitato tutto questo clamore, ma la spiegazione, chiara, viene fornita dal giornalista Bill Reddy sul Syracuse Post-Standard di qualche giorno dopo:
“La parte peggiore è che Gates è nero [adattate sempre il linguaggio, noi preferiamo evitare], uno dei tre neri di una Lega che fino allo scorso anno non ne aveva nessuno. Qualunque altro giocatore avrebbe potuto colpire un avversario senza causare lo stesso furore. Dubito, tuttavia, che altri avrebbero tirato un pugno così bello.”
– Syracuse Post Standard
La vicenda personale tra i due sembra concludersi per il meglio. Entrambi ammetteranno fin da subito le scorrettezze commesse e, nonostante il ricovero di settimane di Meehan, si incontreranno, con Gates che farà recapitare all’avversario addirittura una lettera di scuse.
I Blackhawks, tuttavia, taglieranno Gates prima della fine della stagione, e con lui di lì a poco anche gli altri tre afroamericani sotto contratto. Per molti, su tutti lo storico Christgau, che si è occupato della vicenda diffusamente pubblicando anche un racconto approfondito della partita, la Lega dopo l’episodio aveva deciso semplicemente di purgare gli afroamericani per paura di ripercussioni.
Ci vorrà oltre un anno prima di vedere tornare Gates nella NBL, e non in altre franchigie. I Renaissance, infatti, vengono chiamati dalla Lega per sostituire i Detroit Vagabond Kings, finanziariamente disastrati, e aumentare l’attrattività di un ambiente che stava perdendo pubblico e squadre in favore della concorrente BAA (dove erano migrati, per esempio, i Minneapolis Lakers). I Dayton Rens, questo il nome scelto dalla squadra che rimaneva in tutto e per tutto quella di Harlem, decidono quindi di nominare come giocatore-allenatore proprio Pop, uno dei pochissimi ad avere avuto una precedente esperienza nel campionato.
La stagione non va secondo le aspettative: nonostante le folle oceaniche che per il resto del campionato seguono i Renaissance (si parla addirittura di uscite da 15.000 paganti, roba da Celtics russelliani), Dayton – che ereditava il già poco incoraggiante record di 2-17 – finisce la stagione 16-43, mancando i Playoffs. La presenza della franchigia, tuttavia, rimane comunque determinante: implica, infatti, che per la prima volta in una lega professionistica americana ci sia una squadra a calcare il parquet di soli giocatori di colore, un passo decisivo per la pallacanestro del futuro.
Gli ultimi anni: dai Globetrotters alla Hall of Fame
Terminata la stagione 1948/49, BAA ed NBL trovano un accordo per la fusione e la conseguente nascita della NBA. I Dayton Rens, chiamati solo per l’emergenza-Vagabond Kings, non vengono inclusi nella nuova compagine, perdendo gradualmente ma inesorabilmente la propria fama negli anni successivi. Pop, disoccupato, decide quindi di accasarsi in quella che è l’ “altra” squadra-mito della sua Harlem: i Globetrotters.
Qui, Gates passerà cinque anni da giocatore-allenatore, vedendo da spettatore la scelta di Chuck Cooper e l’ingresso in capo di Earl Lloyd nel 1950. Entrambi verranno ricordati per decenni dalla NBA come i primi afroamericani a rompere la barriera nella Lega. Non una falsità, se si pensa al fatto che in precedenza la Lega non esistesse, ma certamente una svalutazione del ruolo di Pop, degli altri tre giocatori di colore del 1947 e dei Dayton Rens.
Un più che parziale riconoscimento, tuttavia, arriverà nel 1989, quando Cleo Gates, compagna di una vita di William, risponderà ad una telefonata da Springfield, Massachussetts, che intende comunicare a suo marito la prossima introduzione nella Hall of Fame.
Finalmente, a differenza del Clark College, non c’erano più barriere.